English Version
Storia delle antologie di letteratura artistica
Cliccate qui per vedere tutte le antologie recensite
Hermann Uhde-Bernays
Lettere di artisti sull'arte [Künstlerbriefe über Kunst]
Confessioni di pittori, architetti e scultori degli ultimi cinque secoli
Con settanta autoritratti e firme d’artisti
Wolfgang Jess, Dresda, 1926, 968 pagine
Recensione di Francesco Mazzaferro
L’introduzione fu eliminata anche in due successive edizioni dell’antologia, pubblicate questa volta nella Repubblica federale tedesca: una prima edizione tascabile, in due volumi, dell’editore Fischer (Dal Rinascimento ai Romantici, 1960; da Adolf von Menzel ai moderni, 1963); e una seconda versione rilegata in volume unico, co-pubblicata dalla Büchergilde Gutenberg di Francoforte e dalla Nymphenburger Verlag-Handlung di Monaco di Baviera nel 1962. Le due edizioni testimoniano l’interesse del pubblico tedesco dei primi anni Sessanta nei confronti dell’opera, il cui l’autore moriva ormai novantaduenne nel 1965: le Lettere di artisti di Uhde-Bernays si leggevano ancora con piacere quarant’anni dopo la loro prima edizione. Del resto, il genere dell’epistolario artistico era una passione ben consolidata nella cultura tedesca, che era stata inaugurata cent’anni prima da una raccolta di Ernst Karl Guhl nel 1853 (primo volume) [20] e nel 1856 (secondo volume) [21], sulla base delle collezioni italiane del Bottari-Ticozzi (1822-1825), di Giovanni Gaye (1840) e di Michelangelo Gualandi (1840-1845) e che avrà una grande diffusione in Germania proprio fino agli anni Sessanta del Novecento, quando il genere sembra perdere di peso.
La scomparsa nel dopoguerra dell’introduzione – sia nell’edizione della Germania orientale sia nelle due della Germania occidentale – può forse spiegarsi con il semplice fatto che l’idealismo era ormai passato di moda in entrambe le Germanie. Sta di fatto che, dopo quella decurtazione, l’opera originale del 1926 – pensata come lavoro di natura programmatica sul ruolo universale dell’artista nella letteratura artistica – diviene una semplice (sia pur ricchissima) collezione di lettere d’artisti a documento delle loro visioni estetiche negli ultimi cinque secoli.
È evidente come Uhde-Bernays si trovi a pieno agio nell’epoca precedente la I guerra mondiale. Non è un nostalgico dell’impero, ed anzi nutre poca simpatia per l’incolto imperatore Guglielmo II [26], ma gioisce del grado di globalizzazione che la belle époque ha permesso di raggiungere, permettendo alla classe più agiata e colta di attraversare confini fisici e psicologici tra culture e paesi in maniera assai facile. Si considera come erede di un’epoca – l’Ottocento – che a suo parere ha raggiunto l’apice della produzione artistica, persino nel campo della letteratura artistica, raccogliendo l’eredità del mondo rinascimentale. Il crollo di quel mondo pacifico, l’1 agosto 1914 è un trauma per la sua concezione aperta della cultura europea; a tale trauma corrisponde l’incapacità a continuare il suo racconto autobiografico. Nel 1954 compare un volumetto - già citato [27] - con episodi fra loro slegati che si svolgono tra il 1928 ed il 1935; forse erano destinati al secondo volume dell’autobiografia, riferibile agli anni successivi al 1914. Ma una vera e propria seconda parte non fu mai scritta. È lo stesso Uhde-Bernays a dirlo, nella postfazione alla seconda edizione dell’autobiografia [28]. Certamente, è ormai molto anziano e forse non ha più le forze per fare ordine fra le sue memorie. I divieti nazisti di pubblicazione tra 1937 e 1945 gli avevano sottratto anni importanti per completare l’intera biografia. Ma comunque c’è di più, come ha scritto Benno Reifenberg nel recensire la seconda edizione [29]: la Germania che attraversa le esperienze traumatiche di Weimar e del nazismo non è più il suo mondo e Uhde-Bernays decide che non vale la pena dedicarle un libro, nonostante continui a scrivere nuovi volumi di critica d’arte e letteraria fino a età inoltrata. Nella seconda edizione dell’autobiografia nel 1963 aggiunge dunque alla prima parte dell’autobiografia un allegato con una semplice tabella con gli eventi più importanti tra l’inizio della Prima Guerra Mondiale [30] ed il 1958: vi riporta le pubblicazioni e gli impegni professionali, le mostre visitate, i concerti, i viaggi, le vicende degli affetti materiali. Nulla di più. Una sorta di dichiarazione di incapacità ad identificarsi con il mondo dopo il 1914.
L’eredità di Burckhardt
“La narrazione che segue – scrive l’autore nelle prime pagine dell’autobiografia – è stata messa per iscritto con il solo obiettivo di fissare avvenimenti e preziose impressioni di quattro decenni il cui significato va al di là del singolo (…) e di una vita intera di lavoro di un convinto ‘europeo’ interamente spesa (…) per l’ideale di una concezione classica della cultura a seguito dei tre grandi modelli: Goethe, Wilhelm von Humboldt e Jacob Burckhardt.” [31]
Con Jacob Burckhardt (1818-1897) Uhde-Bernays è convinto si sia raggiunto l’apice dell’umanesimo tedesco ed al tempo stesso si siano manifestati i primi presagi della sua caduta. Scrive ancora nell’autobiografia: assieme ai grandi poeti classici “Burckhardt è divenuto l’accompagnatore scientifico al mio fianco, colui che mai mi ha negato una risposta, e che ha influito sul mio sviluppo molto di più di tutti i filosofi dei tempi moderni. Il significato particolare, la capacità di presagire gli avvenimenti politici e la veggenza dello studioso di Basilea mi sono divenuti evidenti nella loro piena dimensione solamente quando le cupe profezie di Spengler si sono avverate ed il declino dell’Occidente si è materializzato. (…) La sua concezione del valore della personalità individuale e la sua generosa visione del mondo, che ricorda Wilhelm von Humboldt, sono superiori agli appelli fuorvianti che Treitschke fa alle ‘regole morali dell’ordine mondiale’. Con il passar degli anni ho elevato i suoi principi a tesi della mia incrollabile fiducia nell’idea nobile ed esemplare di Burckhardt sui compiti della cultura.” [32] Come vedremo, sono i temi fondamentali dell’introduzione delle Lettere. Nell’opposizione tra Burckhardt e Treitschke si cristallizza anche l’origine della diversa evoluzione del liberalismo ottocentesco di lingua tedesca, in senso cosmopolita (Burckhardt) o nazionalista ed antisemita (Treitschke).
I grandi storici dell’arte: Hermann Grimm, Hugo von Tschudi e Julius Meier-Graefe
Hugo von Tschudi è l’uomo che sposa fra loro la cultura viennese (è allievo di Rudolf Eitelberg von Edelberg), l’amore per l’arte tedesca dell’Ottocento (è grande amico di von Marées a Roma) e l’apertura della Germania all’impressionismo francese. Divenuto direttore della Nationalgalerie di Berlino, la rivoluziona acquistando a Parigi trenta opere di impressionisti, emarginando la pittura di genere che fino ad allora aveva dominato il panorama tedesco (Piloty, von Werner) e riscoprendo una vena moderna nell’arte tedesca dell’Ottocento, da Menzel in poi, che si sposa con gli sviluppi francesi. Per questo viene attaccato dall’ Imperatore in persona nel 1908, innescando una reazione (“Il caso Tschudi”) che è il primo episodio di ribellione di circoli ufficiali del mondo della cultura all’establishment politico imperiale. “Tschudi era la figura ideale del buon tedesco ed europeo di grande cultura degli anni precedenti la guerra: mai vincolato dall’ufficialità, sempre devoto alla sostanza culturale della nazione, cui aveva scelto volontariamente d’appartenere [nota dell’editore: era nato come cittadino svizzero], un mediatore e custode del nostro patrimonio, a tal modo puro, che dopo la guerra l’apparizione di tali personalità non sarebbe più stata in linea coi tempi, perché ne mancavano le condizioni indispensabili, anche sociali, che a lui erano state invece concesse.” [37]
Julius Meier-Graefe, infine, è il grande polemista e divulgatore che – all’inizio del 1900 – diffonde la conoscenza degli impressionisti tra il grande pubblico tedesco, evitando che l’interesse nei loro confronti rimanga confinato nel mondo settario delle Secessioni [38]. Nei primi anni del secolo Meier-Graefe si scontra con i sostenitori dell’arte tardo-romantica tedesca ed in particolare con gli ammiratori di Böcklin e Klinger, ed affronta il tema in una monografia dai toni di violentissimo pamphlet (Il caso Böcklin e la lezione delle unità del 1905 [39]) in cui prende pienamente le parti dell’arte francese contro le derive spirituali tedesche. Uhde-Bernays – affezionato alla pittura classicheggiante di Feuerbach – lo appoggia pienamente, vedendo in quegli sviluppi dell’arte tedesca l’espressione del vitalismo tardo-romantico e dei dogmi anti-classicisti a lui tanto avversi [40]. I due si conoscono a Berlino nel 1906, in occasione della “Jahrhundertausstellung deutscher Kunst” (La mostra tedesca del nuovo secolo). Nelle memorie Uhde-Bernays scrive: “Questa mostra memorabile è stata decisiva per il mio rapporto con i pittori tedeschi dell’Ottocento. Il motto della mia generazione ‘Libertà e bellezza’ ha gettato anche me nelle braccia dell’impressionismo, le cui capacità espressive e finalità figurative mi sembrarono avessero un carattere concettuale. Noi eravamo persone che volevano rimanere da questa parte del mondo [nota dell’editore: è un riferimento polemico al simbolismo, e forse alla nozione di Nietzsche ‘al di là del bene e del male’], non traevano alcuna soddisfazione dalle negazioni mistiche o le fantasticherie romantiche e che si erano dunque rivolti al lato solare della vita. Da ciò il nostro entusiasmo per Manet e Renoir, da ciò la nostra approvazione per Liebermann, Trübner e Slevogt” [41]. Sono gli impressionisti tedeschi, che in un solo decennio passano in Germania da avanguardia a reazione: prima rappresentano la ribellione nei confronti della pittura accademica e poi, a partire dal 1910, si devono difendere contro l’avanguardia espressionista. Uhde-Bernays ignoró quest’ultima nella prima edizione delle Lettere nel 1926, ma fu costretto ad includerla nella seconda edizione del 1956.
La mostra del 1906 è co-organizzata da Tschudi e Meier-Graefe, due personalità diversissime, ed eppure una coppia molto efficace. L’esposizione non solamente fa conoscere gli impressionisti al grande pubblico, ma porta alla riscoperta di molti pittori tedeschi dell’Ottocento che erano stati dimenticati (Caspar David Friedrich, Philipp Otto Runge) o che mai erano stati valorizzati fino a quel momento (Wilhelm Leibl, Hans von Marées e Anselm Feuerbach). L’arte francese e quella tedesca vengono riscoperte come momento comune di liberazione dall’Accademia e dalle convenzioni dello stile Biedermeier e dei pittori storici. Con Meier-Graefe ed i cugini Cassirer sta nascendo a Berlino, attorno alla rivista “Kunst und Künstler” (L’arte e gli artisti) quell’ambiente della storia dell’arte cosmopolita (Eberhard von Bodenhausen, Karl Scheffler, Wilhelm Hausenstein e molti altri) che identificherà la propria missione nella diffusione dell’arte francese in Germania, non come un’arte estranea, ma come l’espressione ultima di un’arte universale. Si sviluppa infatti in quegli anni, con Hans Trog, Tschudi, Meier-Graefe, Nemes [42] un’interpretazione dell’impressionismo come categoria eterna dello spirito e volto nuovo della classicità, che trova la propria origine nella scoperta della modernità di Velázquez (Tschudi), El Greco (Meier-Graefe), e Matthias Grünewald.
Nel 1915, in piena guerra mondiale, Uhde-Bernays è uno dei firmatari di un manifesto a favore di Meier-Graefe, contro le accuse di alto tradimento della critica d’arte nazionalista. La lista dei firmatari a suo favore mostra che non si tratta di un nucleo rivoluzionario di critici dell’avanguardia (un gruppo di critici di orientamento rivoluzionario marxista pur esiste, ma non si schiera con Meier-Graefe e di quelle che ritiene siano le sue battaglie borghesi), ma di esponenti di orientamento conservatore, che pure rifiutano “questo tipo di germanicità” [43]. Con la sua collaborazione a Kunst und Kunstler, Uhde-Bernays è parte integrante di questo mondo. L’impressionismo è per Uhde-Bernays la continuazione del mondo di Goethe.
La pittura del classicismo tedesco
Il centro dell’interesse artistico di Uhde-Bernays è Monaco, allora con Parigi una delle capitali dell’arte contemporanea europea, ma anche il polo culturale di un rapporto fortissimo tra Germania e antico mondo classico. Oltre a Anselm Feuerbach – cui dedica una parte importante della propria attività di critico d’arte – egli scrive su Carl Spitzweg (1913) [44] e sui paesaggisti monacensi dell’Ottocento (1921) [45]. La sua monografia su Spitzweg, artista oggi quasi del tutto dimenticato, ha allora grande risonanza, ed è descritta come la monografia di soggetto artistico più letta in Germania negli anni immediatamente precedenti la prima guerra mondiale. Alla pittura monacense dell’Ottocento Uhde-Bernays dedica due volumi nel 1922, insieme a Rudolf Oldenbourg, in cui copre le vicende artistiche dell’ultimo secolo nella capitale bavarese [46].
Monaco è la sede della prima Secessione europea a partire dal 1892 e, anche per via delle riviste rivali Jugend e Simplizissimus, il luogo dove si creano un nuovo stile (il Jugendstil) ed un nuovo genere (la satira politica). L’interesse di Uhde-Bernays non va in realtà tanto alle avanguardie della secessione monacense di fine secolo (Stuck e Lenbach), ma ai classici di metà Ottocento ed al più ai primi romantici, a condizione però che essi sappiano conservare elementi di equilibrio nelle loro creazioni. Come abbiamo detto, egli si oppone ad ogni deriva tardo-romantica e spiritualista; è un dissidio che divide tutto il mondo tedesco di quegli anni (si pensi allo scontro tra i partigiani del romantico classico Brahms ed il romantico estremo Brückner).
Fine Prima Parte
Vai alla Parte Seconda (di prossima pubblicazione)
NOTE
[1] Uhde-Bernays Hermann, Künstlerbriefe über Kunst. Bekenntnisse von Malern, Architekten und Bildhauern aus fünf Jahrhunderten, Mit sechzig Selbstbildnissen und den Künstler-Unterschriften, Verlag von Wolfgang Jess, Dresden, 1926, 967 pagine. Citazione a pagina 7.
[2] Si segnala la positiva recensione di H. Friedeberger uscita nel 1928 su Kunst und Kunstler (la rivista cui Uhde-Bernays collaborò): http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kk1928/0311?sid=88fa5be24c5feb158dffe5bcd8867532
[3] È comunque sorprendente che nella lunga lista degli studiosi cui l’autore rende merito non figuri Julius von Schlosser, che aveva appena pubblicato la sua Kunstliteratur nel 1924. Quel testo, del resto, non include alcun riferimento a Uhde-Bernays.
[4] Kern, Joseph Guido, Uhde-Bernays, Hermann - Anselm Feuerbachs Briefe an seine Mutter, Berlino, Meyer und Jessen, 1911, 304 pagine.
[5] Il testo è accessibile su Internet all’indirizzo: https://archive.org/details/henriettefeuerba00feueuoft
[6] Il testo è accessibile su Internet all’indirizzo: https://archive.org/details/anselmfeuerbachs00feueuoft
[7] Uhde-Bernays, Hermann - Ein Feuerbach-Brevier, Vienna, Meyer und Jessen, 1912, 102 pagine.
[8] Uhde-Bernays, Hermann, Winckelmanns kleine Schriften zur Geschichte der Kunst des Altertums, Lipsia, Insel-Verlag, 1913, 293 pagine.
[9] Uhde-Bernays, Hermann - Johann Joachim Winckelmann: Ausgewählte Schriften, Lipsia, Insel-Verlag, 1914, 87 pagine.
[10] Il testo è accessibile su Internet all’indirizzo:
https://archive.org/stream/neuesvonspitzweg00spit#page/n5/mode/2up
[11] Uhde-Bernays, Hermann: Unbekannte Briefe Winckelmanns, Lipsia, Sammlung Kippenberg, 1921, 79 pagine.
[12] Uhde-Bernays Hermann, Kleine Schriften und Briefe. Kleine Schriften zur Geschichte der Kunst des Altertums und Ausgewählte Briefe, Lipsia, Insel-Verlag, 1925, pagine 292 (primo volume) e 335 (secondo volume).
[13] Uhde-Bernays Hermann, Mein weißes Haus, Zurigo e Stoccarda, Eugen Rentsch Verlag, 1954, 164 pagine
[14] Uhde-Bernays Hermann, Mein weißes Haus, (citato), p. 155.
[15] Il Dizionario Biografico Tedesco conferma che la sanzione fu giustificata dal fatto che Uhde-Bernays rifiutò le tesi nazionaliste del nazismo e non ritrattò le proprie opinioni filo-europee. Si veda https://books.google.de/books?id=-MAlCv4xROAC&pg=PA153&lpg=PA153&dq=uhde-bernays+schreibverbot&source=bl&ots=3DpqyABrS7&sig=GsbH-6gGhhg9jq9H-h0Frx2ajhY&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwitwum-7LDLAhXKpnIKHZxkDzc4ChDoAQg2MAY#v=onepage&q=uhde-bernays%20schreibverbot&f=false .
[16] Uhde-Bernays Hermann, Mein weißes Haus, quoted, p. 156
[17] Citazione tratta da pagina 428 di Uhde-Bernays, Hermann - Im Lichte der Freiheit, Monaco, Nymphenburger Verlagshandlung Insel Verlag, 1963, pagine 607.
[18] Wolfgang Jess, arruolato negli ultimissimi giorni della guerra, era in realtà morto nella battaglia di Berlino. La casa editrice era andata distrutta nel bombardamento di Dresda. Tra il 1947 ed il 1958 la moglie Marianne aveva continuato le pubblicazioni, fino a quando il regime comunista le sottrasse la licenza. Si veda: http://www.stadtwikidd.de/wiki/Verlag_Wolfgang_Jess
[19] Nello stesso anno la medesima edizione compare anche nella Repubblica Federale Tedesca a cura dell’editore Nymphenburger Verlagsbuchhandlung di Monaco di Baviera. È un fatto assai strano, la cui spiegazione è forse che Uhde-Bernays accetta che la pubblicazione sia fatta a Dresda dall’editore ‘storico’ Wolfgang Jess, ma non vuole limitare la circolazione del libro alla Germania orientale, con cui la Germania Occidentale non aveva alcun rapporto, e pubblica perciò un’edizione parallela anche in occidente.
[20] Guhl, Ernst - Künstler - Briefe. Übersetzt und erläutert, Berlino, Trautwein, 1853. Il testo completo è disponibile all’indirizzo https://archive.org/details/kunstlerbriefe01guhl
[21] Guhl, Ernst - Künstler-Briefe. Band 2, Kunst und Künstler des siebzehnten Jahrhunderts, Berlino, Guttentag, 1856. Il testo completo è disponibile all’indirizzo https://archive.org/details/kunstlerbriefe02guhl.
[22] Si veda la voce "Uhde, August Friedrich Hermann Karl" in: Allgemeine Deutsche Biographie 39 (1895), pagine 140-141. http://www.deutsche-biographie.de/pnd117267457.html?anchor=adb.
[23] Uhde-Bernays, Hermann - Im Lichte der Freiheit, Wiesbaden, Insel Verlag, 1948, 535 pagine. Consultata nella seconda edizione rivista del 1963, a cura dell’editore di Monaco di Baviera Nymphenburger Verlagshandlung (607 pagine)
[24] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 10
[25] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 265
[26] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 366
[27] Uhde-Bernays Hermann, Mein weißes Haus, citato.
[28] La seconda edizione, da me consultata, viene terminata nel 1958 e pubblicata nel 1963.
[29] Si veda Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7 marzo 1964, http://www.gbv.de/dms/faz-rez/640307_FAZ_0081_BuZ5_0001.pdf.
[30] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 582.
[31] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 9.
[32] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 428.
[33] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 264.
[34] Uhde-Bernays Hermann, Künstlerbriefe über Kunst, … (citato), p. 9
[35] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 203
[36] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 263
[37] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), pp. 385-386
[38] Rispetto agli sviluppi francesi l’ingresso degli impressionisti è molto tardo, ed avviene quando il movimento artistico a Parigi si è già esaurito ed è stato già sostituito dalle correnti post-impressioniste. A Berlino gli impressionisti entrano solamente nel 1898-1899, addirittura dopo le prime incursioni delle avanguardie con la mostra di Munch, subito proibita, organizzata da Walter Leistikow a Berlino nel 1892. Uhde-Bernays è testimone sia della presenza di Munch, Hamsun e Przybyszewki – artisti e letterati maledetti – nei circoli simbolisti di artisti e letterati (“tutti e tre alcolizzati, poverissimi, spesso senza alcuna idea di come tirare a campare il giorno dopo, e tuttavia decisi a non fare alcuna concessione ai borghesi”, si veda p. 216 di Im Lichte der Freiheit) sia del contemporaneo successo commerciale degli impressionisti nella borghesia della capitale tedesca grazie ai fratelli Cassirer.
[39] L’originale è disponibile all’indirizzo https://archive.org/details/derfallbcklinun00meiegoog
[40] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 361
[41] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 381
[42] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 427
[43] Si veda: Meier-Graefe, Julius - Kunst ist nicht für Kunstgeschichte da: Briefe und Dokumente, Gottinga, Wallstein Verlag, 2001, 574 pagine. Citazione alle pp. 426-426. I firmatari sono: Peter Behrens, Theodor Behrens, Oskar Bie, Eberhard Freiherr von Bodenhausen-Degener, Hugo Bruckmann, Lovis Corinth, Richard Dehmel, Walther Epstein, Paul Fechter, H.A. Graf Harrach, Kurt Herrmann, Adolf von Hildebrand, Hugo von Hofmannsthal, Georg Kolbe, Leo Freiherr von König, H.E. Lind-Walther, Julius Levin, Kurt Freiherr von Mutzenbecher, Karl Ernst Osthaus, Gustav Pauli, Hermann vom Rath, R.A. Schröder, Eugen Spiro, Georg Swarzenski, Louis Tuallon, H. Uhde-Bernays, Lutz Wolde, Heinrich Wölfflin.
[44] L’originale è disponibile all’indirizzo https://archive.org/details/carlspitzwegdesm00uhdeuoft.
[45] L’originale è disponibile all’indirizzo: https://archive.org/details/mnchenerlandsc00uhdeuoft.
[46] Oldenbourg, Rudolf e Uhde-Bernays, Hermann - Die Münchner Malerei im neunzehnten Jahrhundert. Teil I: Die Epoche Max Josephs und Ludwigs I. II.Teil: 1850-1900. Mit zahlreichen Abbildungen im Text. Monaco, Verlag F. Bruckmann A.-G., 1922, pagine 302 e 303.
https://letteraturaartistica.blogspot.com/2015/11/gottfried-semper.html
 |
| Fig. 1) L’edizione originale delle Lettere di artisti sull’arte di Hermann Uhde-Bernays, pubblicata da Wolfgang Jess a Dresda nel 1926 |
Un’opera
programmatica oggi dimenticata
L’antologia di lettere sull’arte di Hermann
Uhde-Bernays (1873-1965) viene pubblicata nel 1926, durante la Repubblica di
Weimar, in un elegante e pregevole volume dell’editore Wolfgang Jess destinato a
piacere sia al grande pubblico sia ai bibliofili. L’autore fu professore di
letteratura moderna all’Università di Monaco di Baviera e artefice di una serie
importante di pubblicazioni di critica d’arte, con particolare attenzione all’Ottocento. La raccolta contiene 350 lettere, scelte “a condizione che
abbiano un prevalente interesse estetico invece che biografico” [1]. Si apre
con Leon Battista Alberti e si conclude con Van Gogh. In un’appendice il
lettore viene dettagliatamente informato della data e della fonte di ogni
lettera. Ottimo l’indice delle persone citate. Le lettere sono presentate in
ordine cronologico, in sei capitoli. Il primo si apre con i grandi del
Rinascimento (Alberti, Dürer, Raffaello, Leonardo, Michelangelo e altri ancora)
e si conclude con Rembrandt, Rubens e Poussin. Il secondo è dedicato agli
accademici francesi (tra i quali Lebrun, Watteau, Cochin, Falconet, Greuze),
seguiti da Tiepolo, i settecentisti tedeschi (Neumann, Mengs, Tischbein e molti
altri) ed inglesi (Hogarth, Reynolds, Gainsborough). Il terzo capitolo è
dedicato al primo Ottocento tedesco (Schadow, Schinkel, von Cornelius, Schnorr,
Overbeck, Pforr, Veit, Runge, Steinle, Richter, Lessing, Semper fra i tanti).
Con il quarto capitolo si percorre il lungo sentiero dalla seconda metà
dell’Ottocento tedesco, fino a raggiungere le Secessioni ed addirittura gli
espressionisti del primo Novecento: Menzel, Böcklin, Anselm Feuerbach, von
Marées, Leibl, Klinger, Liebermann, Thoma, Corinth, Slevogt, Hodler, Marc,
Paula Modersohn, Beckmann, Kubin. Il quinto capitolo è dedicato all’Ottocento
francese, a partire da David, Géricault e Delacroix per continuare con Corot,
Millet, Fromentin, Puvis de Chauvannes, Daumier, Courbet etc… Seguono gli
impressionisti (Manet, Monet) e i post-impressionisti (per citare solo alcuni:
Pisarro, Cézanne, Sisley, Signac, Gauguin, Rops, Rodin). Il sesto ed ultimo
capitolo è dedicato al resto d’Europa: si apre con Canova, Thorvaldsen,
Constable e Turner, presenta Rossetti, Burne Jones e Whistler, e termina con
Segantini, con un giovanissimo Picasso e infine con van Gogh. È evidente
l’intenzione di offrire una visione universale della letteratura artistica in
forma epistolare, tale da collocare il mondo tedesco come parte integrante del
corso universale della storia dell’arte. L’edizione è arricchita dalla riproduzione
di sessanta autoritratti, alla base di ognuno dei quali è riprodotta anche la
firma dell’artista [2]. Vale la pena ricordare che, se al momento della
pubblicazione, esistevano già raccolte di lettere in tedesco relativamente a
periodi come il Rinascimento, il Barocco e l’Ottocento, in altri casi (il
Settecento, ad esempio) Uhde-Bernays rese disponibile al pubblico materiale
assai difficile da rintracciare.
 |
| Fig. 2) Hermann Struck, Ritratto del Prof. Hermann Uhde-Bernays, 1927 |
Uhde-Bernays si dedicava alla letteratura
artistica da molto prima dell’uscita della presente antologia [3]. In
particolare si era dato in più occasioni alla curatela dell’opera di Anselm
Feuberbach: in primo luogo, aveva pubblicato un’edizione, in due volumi, delle
Lettere alla madre, (in coppia con Joseph
Guido Kern, 1911) [4], facendole seguire da una Biografia di Henriette Feuerbach attraverso le lettere (1912) [5],
da una seconda edizione in un solo volume delle Lettere alla madre (1912) [6], e da un Breviario di Feuerbach (1912) [7]. Va qui detto che la madre di
Anselm Feuerbach, Henriette, fu figura di primissimo piano nella letteratura e
nella musica tedesca dell’Ottocento (fu grande amica di Brahms e di Clara
Schumann), che fu donna di cultura eccezionale e che la corrispondenza fra lei
ed il figlio Anselm testimonia con ricchezza la vita culturale in Germania (ed
in Italia). Una parte consistente dell’epistolario di Henriette era nelle mani
di Michael Bernays, amato patrigno di Hermann: si spiega in questo il motivo di
tanta attenzione da parte del nostro.
 |
| Fig. 3) Lettere scelte di Anselm Feuerbach alla madre, selezionate da Hermann Uhde Bernays, 1920 |
 |
| Fig. 4) Anselm Feuerbach, Ritratto di Henriette Feuerbach, 1877 |
Oltre a Feuberbach, vanno poi ricordate, sempre
tra le opere di letteratura artistica a cura del critico tedesco, anche le Opere Minori sulla storia dell’antichità (1913)
[8] e gli Scritti scelti di Winckelmann
(1914) [9], le Poesie e Lettere del
pittore Carl Spitzweg (1918) [10], le Lettere
inedite di Winckelmann (1921) [11], edite con Konrad Friedrich Uden e Adam
Friedrich Oeser, ed infine i due volumi delle Opere minori e Lettere di Winckelmann (1925) [12].
 |
| Fig. 5) Johann Joachim Winckelmann, Scritti scelti, 1914 |
 |
| Fig. 6) Johann Joachim Winckelmann, Scritti minori e lettere, Primo volume: Scritti minori sulla storia dell’antichità, a cura di Hermann Uhde-Bernays, nell’edizione del 1925 |
Come in molti altri casi, anche per Uhde-Bernays
l’avvento del nazismo significa un’esperienza traumatica. Egli stesso lo
racconta nella postfazione ad un volumetto di ricordi del 1954 [13]. Perché
potesse continuare la sua attività pubblicistica senza controlli politici, gli
fu infatti intimato di iscriversi alla Reichsschrifttumskammer,
un’istituzione creata da Goebbels nel 1933 per controllare la cultura tedesca.
Al suo rifiuto, la sua possibilità di pubblicare articoli e libri divenne
oggetto di sostanziale censura, motivo per cui Uhde-Bernays preferì ritirarsi
nelle sue amatissime Alpi bavaresi, nella cittadina di Stanberg (ma negli anni
più difficili si rifugiò anche in Svizzera) e decise unilateralmente di non far
uso delle difficili procedure per far domanda di pubblicazione, chiudendosi in
“esilio spirituale” [14]. Le
limitazioni al diritto di pubblicare e, nei casi più estremi, la sanzione dello
Schreibverbot (ovvero il divieto non
solo alla pubblicazione, ma anche al ricorso alla scrittura, se non ad uso
esclusivamente personale) erano inflitte dalle autorità naziste ai cittadini
tedeschi che non potevano essere considerati nemici per ragioni politiche o
razziali (anche se il patrigno Michael Bernays era di discendenza ebraica), ma
la cui opera era comunque considerata contraria alla linea ufficiale del
partito. Nel caso specifico la pena era dovuta all’orientamento troppo
filoeuropeo del critico [15]: non a caso Uhde-Bernays aveva soprannominato la propria biblioteca
privata “Alt-Europa Zimmer”, ovvero
la “camera della vecchia Europa” [16]. Quel nome era una citazione da Jacob Burckhardt contenuta in una lettera dello storico svizzero del 1846. In essa
Burckhardt descriveva la missione della sua vita: “Io voglio aiutare a salvare quel che rimane del mio debole mondo. Tutti
possiamo fallire, ma io voglio almeno scegliere un interesse per il quale
voglio fallire, ovvero salvare l’istruzione della vecchia Europa.” [17]
 |
| Fig. 7) Anselm Feuerbach, Medea, 1870 |
Dopo la guerra Uhde-Bernays riacquisì ovviamente i
diritti civili e divenne nel 1946, ormai settantatreenne, professore onorario
di letteratura moderna, mentre dal 1951 fu per qualche anno membro dell’Accademia tedesca per la lingua e la poesia (Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung). La sua attività fu
dunque sempre centrata sull’incrocio tra arte e letteratura, con un ruolo
fondamentale sempre affidato alla parola scritta.
 |
| Fig. 8) Le Memorie di Hermann Uhde-Bernays (1880-1914), nell’edizione pubblicata nel 1963 |
Nel 1956, a trent’anni di distanza dalla prima
edizione, Uhde-Bernays presentò una seconda edizione rivista della sua
antologia. Furono aggiunte 48 lettere, mentre altre vennero eliminate (in
totale si passava da 350 a 375 lettere); per tener conto dei nuovi sviluppi
intervenuti negli ultimi trent’anni si estese la raccolta da van Gogh fino a
Kandinsky. Il volume – anche in questo caso un’edizione pregiata per bibliofili
- fu pubblicato ad opera del medesimo editore Wolfgang Jess [18] di Dresda, che nel frattempo si era trovata nella Repubblica Democratica Tedesca [19] e con un’altra
importante differenza: mentre veniva aggiornata la postfazione, la ricchissima
introduzione del 1926, un vero e proprio manifesto della letteratura artistica
dal punto di vista dell’idealismo tedesco, scomparì del tutto. A mo’
d’introduzione rimasero semplicemente due versi Goethe: “Trovate in uno i molti, vivete i molti come uno / ed avete l’inizio,
avete la fine dell’arte.”
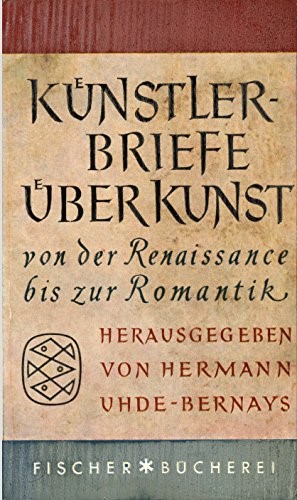 |
| Fig. 9) Il primo volume dell’edizione tascabile delle Lettere di artisti, pubblicato nel 1960 |
L’introduzione fu eliminata anche in due successive edizioni dell’antologia, pubblicate questa volta nella Repubblica federale tedesca: una prima edizione tascabile, in due volumi, dell’editore Fischer (Dal Rinascimento ai Romantici, 1960; da Adolf von Menzel ai moderni, 1963); e una seconda versione rilegata in volume unico, co-pubblicata dalla Büchergilde Gutenberg di Francoforte e dalla Nymphenburger Verlag-Handlung di Monaco di Baviera nel 1962. Le due edizioni testimoniano l’interesse del pubblico tedesco dei primi anni Sessanta nei confronti dell’opera, il cui l’autore moriva ormai novantaduenne nel 1965: le Lettere di artisti di Uhde-Bernays si leggevano ancora con piacere quarant’anni dopo la loro prima edizione. Del resto, il genere dell’epistolario artistico era una passione ben consolidata nella cultura tedesca, che era stata inaugurata cent’anni prima da una raccolta di Ernst Karl Guhl nel 1853 (primo volume) [20] e nel 1856 (secondo volume) [21], sulla base delle collezioni italiane del Bottari-Ticozzi (1822-1825), di Giovanni Gaye (1840) e di Michelangelo Gualandi (1840-1845) e che avrà una grande diffusione in Germania proprio fino agli anni Sessanta del Novecento, quando il genere sembra perdere di peso.
 |
| Fig. 10) L’edizione delle Lettere di artisti del 1962 |
La scomparsa nel dopoguerra dell’introduzione – sia nell’edizione della Germania orientale sia nelle due della Germania occidentale – può forse spiegarsi con il semplice fatto che l’idealismo era ormai passato di moda in entrambe le Germanie. Sta di fatto che, dopo quella decurtazione, l’opera originale del 1926 – pensata come lavoro di natura programmatica sul ruolo universale dell’artista nella letteratura artistica – diviene una semplice (sia pur ricchissima) collezione di lettere d’artisti a documento delle loro visioni estetiche negli ultimi cinque secoli.
Dal momento che quell’introduzione aveva
importanza per studiare il corso della letteratura artistica in anni
fondamentali per la sua nascita come genere intermedio tra critica d’arte e
critica letteraria, mi è sembrato opportuno riportarla in allegato, pur nella
difficoltà di traduzione del testo, insieme alla postfazione in cui l’autore
spiega le motivazioni e la gestazione dell’opera (si veda la Parte Seconda).
 |
| Fig. 11) Fritz von Uhde, Due bambine, 1909 |
Storico
d’arte, critico letterario e pubblicista
Hermann Uhde-Bernays nasce in un ambiente di
grandissima cultura. Il padre, Hermann Uhde (1845–1879), venuto a mancare quando lui
era ancora bambino, era uno studioso di Goethe [22]; il secondo marito della
madre (Michel Bernays – 1834-1897) ed il di lui fratello Jacob Bernays
(1824-1881) furono rinomati filologi. Nella sua autobiografia Im Lichte der Freiheit (Sotto la luce
della libertà) [23] pubblicata nel 1947, ma riferita solamente agli anni
1880-1914, Hermann ci racconta dell’adorazione che provava nei confronti del
patrigno, che aveva dedicato la vita intera “alle creazioni dei grandi poeti e scrittori di tutti i tempi e tutti i
popoli” [24]. Non a caso decide di aggiungere al suo anche il cognome
Bernays. Fin dalla gioventù, il suo è un mondo tutto dedicato all’arte, alla
letteratura, alla musica ed al teatro, trascorso tra Germania, Italia (dodici
viaggi lungo l’intera vita) e Francia in una devozione totale al mondo classico,
al rinascimento, all’arte tedesca dell’Ottocento ed all’impressionismo
francese. Il suo interesse continuo per la letteratura artistica nasce
dall’incrocio della passione di critico d’arte con la sua cultura umanistica, e
dalla sua incredibile capacità di lettura [25]. Lavora alla Frankfurter Zeitung di Francoforte e al Deutsche Tageszeitung di Berlino come
critico letterario, musicale e drammatico, e da lì documenta per alcuni anni la
vita intellettuale di Monaco, capitale culturale della Germania prima che il
centro delle arti si sposti definitivamente a Berlino. Sarà giornalista e
pubblicista fino al 1914, e poi si dedicherà all’insegnamento.
 |
| Fig. 12) Carl Spitzweg, L’alchimista, 1860 circa |
È evidente come Uhde-Bernays si trovi a pieno agio nell’epoca precedente la I guerra mondiale. Non è un nostalgico dell’impero, ed anzi nutre poca simpatia per l’incolto imperatore Guglielmo II [26], ma gioisce del grado di globalizzazione che la belle époque ha permesso di raggiungere, permettendo alla classe più agiata e colta di attraversare confini fisici e psicologici tra culture e paesi in maniera assai facile. Si considera come erede di un’epoca – l’Ottocento – che a suo parere ha raggiunto l’apice della produzione artistica, persino nel campo della letteratura artistica, raccogliendo l’eredità del mondo rinascimentale. Il crollo di quel mondo pacifico, l’1 agosto 1914 è un trauma per la sua concezione aperta della cultura europea; a tale trauma corrisponde l’incapacità a continuare il suo racconto autobiografico. Nel 1954 compare un volumetto - già citato [27] - con episodi fra loro slegati che si svolgono tra il 1928 ed il 1935; forse erano destinati al secondo volume dell’autobiografia, riferibile agli anni successivi al 1914. Ma una vera e propria seconda parte non fu mai scritta. È lo stesso Uhde-Bernays a dirlo, nella postfazione alla seconda edizione dell’autobiografia [28]. Certamente, è ormai molto anziano e forse non ha più le forze per fare ordine fra le sue memorie. I divieti nazisti di pubblicazione tra 1937 e 1945 gli avevano sottratto anni importanti per completare l’intera biografia. Ma comunque c’è di più, come ha scritto Benno Reifenberg nel recensire la seconda edizione [29]: la Germania che attraversa le esperienze traumatiche di Weimar e del nazismo non è più il suo mondo e Uhde-Bernays decide che non vale la pena dedicarle un libro, nonostante continui a scrivere nuovi volumi di critica d’arte e letteraria fino a età inoltrata. Nella seconda edizione dell’autobiografia nel 1963 aggiunge dunque alla prima parte dell’autobiografia un allegato con una semplice tabella con gli eventi più importanti tra l’inizio della Prima Guerra Mondiale [30] ed il 1958: vi riporta le pubblicazioni e gli impegni professionali, le mostre visitate, i concerti, i viaggi, le vicende degli affetti materiali. Nulla di più. Una sorta di dichiarazione di incapacità ad identificarsi con il mondo dopo il 1914.
L’eredità di Burckhardt
 |
| Fig. 13) Anselm Feuerbach, La caduta dei titani, 1878-1879 |
“La narrazione che segue – scrive l’autore nelle prime pagine dell’autobiografia – è stata messa per iscritto con il solo obiettivo di fissare avvenimenti e preziose impressioni di quattro decenni il cui significato va al di là del singolo (…) e di una vita intera di lavoro di un convinto ‘europeo’ interamente spesa (…) per l’ideale di una concezione classica della cultura a seguito dei tre grandi modelli: Goethe, Wilhelm von Humboldt e Jacob Burckhardt.” [31]
 |
| Fig. 14) Max Josef Wagenbauer, La riva orientale del Lago di Starnberg, 1813 |
Con Jacob Burckhardt (1818-1897) Uhde-Bernays è convinto si sia raggiunto l’apice dell’umanesimo tedesco ed al tempo stesso si siano manifestati i primi presagi della sua caduta. Scrive ancora nell’autobiografia: assieme ai grandi poeti classici “Burckhardt è divenuto l’accompagnatore scientifico al mio fianco, colui che mai mi ha negato una risposta, e che ha influito sul mio sviluppo molto di più di tutti i filosofi dei tempi moderni. Il significato particolare, la capacità di presagire gli avvenimenti politici e la veggenza dello studioso di Basilea mi sono divenuti evidenti nella loro piena dimensione solamente quando le cupe profezie di Spengler si sono avverate ed il declino dell’Occidente si è materializzato. (…) La sua concezione del valore della personalità individuale e la sua generosa visione del mondo, che ricorda Wilhelm von Humboldt, sono superiori agli appelli fuorvianti che Treitschke fa alle ‘regole morali dell’ordine mondiale’. Con il passar degli anni ho elevato i suoi principi a tesi della mia incrollabile fiducia nell’idea nobile ed esemplare di Burckhardt sui compiti della cultura.” [32] Come vedremo, sono i temi fondamentali dell’introduzione delle Lettere. Nell’opposizione tra Burckhardt e Treitschke si cristallizza anche l’origine della diversa evoluzione del liberalismo ottocentesco di lingua tedesca, in senso cosmopolita (Burckhardt) o nazionalista ed antisemita (Treitschke).
Più in generale, Uhde-Bernays non nasconde la
propria contrarietà allo sviluppo in senso vitalistico della cultura tedesca.
Come si legge non solamente nelle memorie [33], ma anche nelle pagine
introduttive alle Lettere, non gli
piace l’irrazionalismo introdotto nella cultura tedesca da Schopenhauer e
Nietzsche: “La base formativa su cui si è
potuta educare una nuova generazione si è posta anni fa, quando una
riconoscenza splendidamente riverente sosteneva ancora i templi della cultura
tedesca, che oggi giacciono in rovina; allora la silenziosa operosità degli
studiosi dell’epoca dei nostri padri si trasferì consapevolmente su percorsi più
ampi e apprese a sempre utilizzare giudizi razionali per formarsi un’opinione.
Allora ad una gioventù piena di speranza (che finalmente aveva guadagnato
accesso alla natura stessa… e dall’arte impressionista aveva formato un suo
modo di pensare impressionista, e infine piena di giubilo aveva deriso tutte le
negazioni di Schopenhauer o di Nietzsche) si rivelò l’idea della grandezza del
fatto artistico in modo più chiaro di quanto sia mai stato il caso in seguito,
nonostante tutti gli altisonanti discorsi contrari.” [34]
 |
| Fig. 15) Karl Haider, Lo studioso della natura, 1898 |
I grandi storici dell’arte: Hermann Grimm, Hugo von Tschudi e Julius Meier-Graefe
Tra gli storici dell’arte, i grandi maestri di Uhde-Bernays
sono Hermann Grimm (1828-1901), Hugo von Tschudi (1851-1911) e Julius
Meier-Graefe (1867-1935). Su di loro si leggono pagine molto belle
nell’autobiografia. Il primo è molto anziano quando Uhde-Bernays frequenta,
come giovane studente, le sue lezioni a Berlino su Raffaello e lo incontra,
mentre borbotta tra sé e sé, nel parco centrale della città, il Tiergarten.
L’anziano critico morirà in quegli anni. Si trattò senza dubbio di uno dei
grandi padri della storia dell’arte tedesca, ma anche di un riconosciuto
filologo (traduce l’Iliade in tedesco) e di un indiscusso studioso di
germanistica. È proprio questa capacità di incrociare arte e letteratura a fare
di lui un idolo per il giovane studente, che varca continuamente i confini fra
le due discipline. Non senza un tono di amarezza che forse risente di
esperienze personali, Uhde-Bernays osserva che, nonostante l’indiscutibile
prestigio, l’amore per la letteratura è motivo per cui Grimm viene schernito
tra i critici d’arte, che lo chiamano “il
letterato” [35]. Da Grimm deriva la centralità dell’individuo, ed anche il
rifiuto di elaborare ogni teoria schematica che includa le opere (e gli scritti
d’artisti) in forme analitiche rigide. Spiega nell’autobiografia: “Come allievo di Hermann Grimm non avrei mai
adottato una concezione della storia che non consideri irrinunciabile l’effetto
su di essa dei grandi individui.” [36] È anche il tema principale
dell’introduzione alle Lettere.
 |
| Fig. 16) Adolph von Menzel, In birreria, 1883 |
 |
| Fig. 17) Wilhelm Leibl, Ragazze fanno l’uncinetto sul banco della stufa, 1895 |
Hugo von Tschudi è l’uomo che sposa fra loro la cultura viennese (è allievo di Rudolf Eitelberg von Edelberg), l’amore per l’arte tedesca dell’Ottocento (è grande amico di von Marées a Roma) e l’apertura della Germania all’impressionismo francese. Divenuto direttore della Nationalgalerie di Berlino, la rivoluziona acquistando a Parigi trenta opere di impressionisti, emarginando la pittura di genere che fino ad allora aveva dominato il panorama tedesco (Piloty, von Werner) e riscoprendo una vena moderna nell’arte tedesca dell’Ottocento, da Menzel in poi, che si sposa con gli sviluppi francesi. Per questo viene attaccato dall’ Imperatore in persona nel 1908, innescando una reazione (“Il caso Tschudi”) che è il primo episodio di ribellione di circoli ufficiali del mondo della cultura all’establishment politico imperiale. “Tschudi era la figura ideale del buon tedesco ed europeo di grande cultura degli anni precedenti la guerra: mai vincolato dall’ufficialità, sempre devoto alla sostanza culturale della nazione, cui aveva scelto volontariamente d’appartenere [nota dell’editore: era nato come cittadino svizzero], un mediatore e custode del nostro patrimonio, a tal modo puro, che dopo la guerra l’apparizione di tali personalità non sarebbe più stata in linea coi tempi, perché ne mancavano le condizioni indispensabili, anche sociali, che a lui erano state invece concesse.” [37]
 |
| Fig. 18) Da “Kunst für alle” del 15 aprile 1908: la difesa di Hugo von Tschudi (l’illustrazione si riferisce ad altro argomento) |
Julius Meier-Graefe, infine, è il grande polemista e divulgatore che – all’inizio del 1900 – diffonde la conoscenza degli impressionisti tra il grande pubblico tedesco, evitando che l’interesse nei loro confronti rimanga confinato nel mondo settario delle Secessioni [38]. Nei primi anni del secolo Meier-Graefe si scontra con i sostenitori dell’arte tardo-romantica tedesca ed in particolare con gli ammiratori di Böcklin e Klinger, ed affronta il tema in una monografia dai toni di violentissimo pamphlet (Il caso Böcklin e la lezione delle unità del 1905 [39]) in cui prende pienamente le parti dell’arte francese contro le derive spirituali tedesche. Uhde-Bernays – affezionato alla pittura classicheggiante di Feuerbach – lo appoggia pienamente, vedendo in quegli sviluppi dell’arte tedesca l’espressione del vitalismo tardo-romantico e dei dogmi anti-classicisti a lui tanto avversi [40]. I due si conoscono a Berlino nel 1906, in occasione della “Jahrhundertausstellung deutscher Kunst” (La mostra tedesca del nuovo secolo). Nelle memorie Uhde-Bernays scrive: “Questa mostra memorabile è stata decisiva per il mio rapporto con i pittori tedeschi dell’Ottocento. Il motto della mia generazione ‘Libertà e bellezza’ ha gettato anche me nelle braccia dell’impressionismo, le cui capacità espressive e finalità figurative mi sembrarono avessero un carattere concettuale. Noi eravamo persone che volevano rimanere da questa parte del mondo [nota dell’editore: è un riferimento polemico al simbolismo, e forse alla nozione di Nietzsche ‘al di là del bene e del male’], non traevano alcuna soddisfazione dalle negazioni mistiche o le fantasticherie romantiche e che si erano dunque rivolti al lato solare della vita. Da ciò il nostro entusiasmo per Manet e Renoir, da ciò la nostra approvazione per Liebermann, Trübner e Slevogt” [41]. Sono gli impressionisti tedeschi, che in un solo decennio passano in Germania da avanguardia a reazione: prima rappresentano la ribellione nei confronti della pittura accademica e poi, a partire dal 1910, si devono difendere contro l’avanguardia espressionista. Uhde-Bernays ignoró quest’ultima nella prima edizione delle Lettere nel 1926, ma fu costretto ad includerla nella seconda edizione del 1956.
 |
| Fig. 19) Max Liebermann, Il giardino dell’artista, 1918 |
 |
| Fig. 20) Wilhelm Trübner, Villa in primavera, 1918 |
 |
| Fig. 21) Max Slevogt, Angolo assolato del giardino, 1921 |
La mostra del 1906 è co-organizzata da Tschudi e Meier-Graefe, due personalità diversissime, ed eppure una coppia molto efficace. L’esposizione non solamente fa conoscere gli impressionisti al grande pubblico, ma porta alla riscoperta di molti pittori tedeschi dell’Ottocento che erano stati dimenticati (Caspar David Friedrich, Philipp Otto Runge) o che mai erano stati valorizzati fino a quel momento (Wilhelm Leibl, Hans von Marées e Anselm Feuerbach). L’arte francese e quella tedesca vengono riscoperte come momento comune di liberazione dall’Accademia e dalle convenzioni dello stile Biedermeier e dei pittori storici. Con Meier-Graefe ed i cugini Cassirer sta nascendo a Berlino, attorno alla rivista “Kunst und Künstler” (L’arte e gli artisti) quell’ambiente della storia dell’arte cosmopolita (Eberhard von Bodenhausen, Karl Scheffler, Wilhelm Hausenstein e molti altri) che identificherà la propria missione nella diffusione dell’arte francese in Germania, non come un’arte estranea, ma come l’espressione ultima di un’arte universale. Si sviluppa infatti in quegli anni, con Hans Trog, Tschudi, Meier-Graefe, Nemes [42] un’interpretazione dell’impressionismo come categoria eterna dello spirito e volto nuovo della classicità, che trova la propria origine nella scoperta della modernità di Velázquez (Tschudi), El Greco (Meier-Graefe), e Matthias Grünewald.
 |
| Fig. 22) Il primo numero di Kunst und Künstler nel 1902 |
Nel 1915, in piena guerra mondiale, Uhde-Bernays è uno dei firmatari di un manifesto a favore di Meier-Graefe, contro le accuse di alto tradimento della critica d’arte nazionalista. La lista dei firmatari a suo favore mostra che non si tratta di un nucleo rivoluzionario di critici dell’avanguardia (un gruppo di critici di orientamento rivoluzionario marxista pur esiste, ma non si schiera con Meier-Graefe e di quelle che ritiene siano le sue battaglie borghesi), ma di esponenti di orientamento conservatore, che pure rifiutano “questo tipo di germanicità” [43]. Con la sua collaborazione a Kunst und Kunstler, Uhde-Bernays è parte integrante di questo mondo. L’impressionismo è per Uhde-Bernays la continuazione del mondo di Goethe.
La pittura del classicismo tedesco
 |
| Fig. 23) Carl Spitzweg, Il poeta povero, 1839 |
Il centro dell’interesse artistico di Uhde-Bernays è Monaco, allora con Parigi una delle capitali dell’arte contemporanea europea, ma anche il polo culturale di un rapporto fortissimo tra Germania e antico mondo classico. Oltre a Anselm Feuerbach – cui dedica una parte importante della propria attività di critico d’arte – egli scrive su Carl Spitzweg (1913) [44] e sui paesaggisti monacensi dell’Ottocento (1921) [45]. La sua monografia su Spitzweg, artista oggi quasi del tutto dimenticato, ha allora grande risonanza, ed è descritta come la monografia di soggetto artistico più letta in Germania negli anni immediatamente precedenti la prima guerra mondiale. Alla pittura monacense dell’Ottocento Uhde-Bernays dedica due volumi nel 1922, insieme a Rudolf Oldenbourg, in cui copre le vicende artistiche dell’ultimo secolo nella capitale bavarese [46].
 |
| Fig. 24) Anselm Feuerbach, Francesca da Rimini e Paolo Malatesta, 1864 circa |
Monaco è la sede della prima Secessione europea a partire dal 1892 e, anche per via delle riviste rivali Jugend e Simplizissimus, il luogo dove si creano un nuovo stile (il Jugendstil) ed un nuovo genere (la satira politica). L’interesse di Uhde-Bernays non va in realtà tanto alle avanguardie della secessione monacense di fine secolo (Stuck e Lenbach), ma ai classici di metà Ottocento ed al più ai primi romantici, a condizione però che essi sappiano conservare elementi di equilibrio nelle loro creazioni. Come abbiamo detto, egli si oppone ad ogni deriva tardo-romantica e spiritualista; è un dissidio che divide tutto il mondo tedesco di quegli anni (si pensi allo scontro tra i partigiani del romantico classico Brahms ed il romantico estremo Brückner).
 |
| Fig. 25) Anselm Feuerbach, Il simposio di Platone (Prima versione), 1869 |
 |
| Fig. 26) Anselm Feuerbach, Il simposio di Platone (Seconda versione), 1871-1874 |
Vai alla Parte Seconda (di prossima pubblicazione)
NOTE
[1] Uhde-Bernays Hermann, Künstlerbriefe über Kunst. Bekenntnisse von Malern, Architekten und Bildhauern aus fünf Jahrhunderten, Mit sechzig Selbstbildnissen und den Künstler-Unterschriften, Verlag von Wolfgang Jess, Dresden, 1926, 967 pagine. Citazione a pagina 7.
[2] Si segnala la positiva recensione di H. Friedeberger uscita nel 1928 su Kunst und Kunstler (la rivista cui Uhde-Bernays collaborò): http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kk1928/0311?sid=88fa5be24c5feb158dffe5bcd8867532
[3] È comunque sorprendente che nella lunga lista degli studiosi cui l’autore rende merito non figuri Julius von Schlosser, che aveva appena pubblicato la sua Kunstliteratur nel 1924. Quel testo, del resto, non include alcun riferimento a Uhde-Bernays.
[4] Kern, Joseph Guido, Uhde-Bernays, Hermann - Anselm Feuerbachs Briefe an seine Mutter, Berlino, Meyer und Jessen, 1911, 304 pagine.
[5] Il testo è accessibile su Internet all’indirizzo: https://archive.org/details/henriettefeuerba00feueuoft
[6] Il testo è accessibile su Internet all’indirizzo: https://archive.org/details/anselmfeuerbachs00feueuoft
[7] Uhde-Bernays, Hermann - Ein Feuerbach-Brevier, Vienna, Meyer und Jessen, 1912, 102 pagine.
[8] Uhde-Bernays, Hermann, Winckelmanns kleine Schriften zur Geschichte der Kunst des Altertums, Lipsia, Insel-Verlag, 1913, 293 pagine.
[9] Uhde-Bernays, Hermann - Johann Joachim Winckelmann: Ausgewählte Schriften, Lipsia, Insel-Verlag, 1914, 87 pagine.
[10] Il testo è accessibile su Internet all’indirizzo:
https://archive.org/stream/neuesvonspitzweg00spit#page/n5/mode/2up
[11] Uhde-Bernays, Hermann: Unbekannte Briefe Winckelmanns, Lipsia, Sammlung Kippenberg, 1921, 79 pagine.
[12] Uhde-Bernays Hermann, Kleine Schriften und Briefe. Kleine Schriften zur Geschichte der Kunst des Altertums und Ausgewählte Briefe, Lipsia, Insel-Verlag, 1925, pagine 292 (primo volume) e 335 (secondo volume).
[13] Uhde-Bernays Hermann, Mein weißes Haus, Zurigo e Stoccarda, Eugen Rentsch Verlag, 1954, 164 pagine
[14] Uhde-Bernays Hermann, Mein weißes Haus, (citato), p. 155.
[15] Il Dizionario Biografico Tedesco conferma che la sanzione fu giustificata dal fatto che Uhde-Bernays rifiutò le tesi nazionaliste del nazismo e non ritrattò le proprie opinioni filo-europee. Si veda https://books.google.de/books?id=-MAlCv4xROAC&pg=PA153&lpg=PA153&dq=uhde-bernays+schreibverbot&source=bl&ots=3DpqyABrS7&sig=GsbH-6gGhhg9jq9H-h0Frx2ajhY&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwitwum-7LDLAhXKpnIKHZxkDzc4ChDoAQg2MAY#v=onepage&q=uhde-bernays%20schreibverbot&f=false .
[16] Uhde-Bernays Hermann, Mein weißes Haus, quoted, p. 156
[17] Citazione tratta da pagina 428 di Uhde-Bernays, Hermann - Im Lichte der Freiheit, Monaco, Nymphenburger Verlagshandlung Insel Verlag, 1963, pagine 607.
[18] Wolfgang Jess, arruolato negli ultimissimi giorni della guerra, era in realtà morto nella battaglia di Berlino. La casa editrice era andata distrutta nel bombardamento di Dresda. Tra il 1947 ed il 1958 la moglie Marianne aveva continuato le pubblicazioni, fino a quando il regime comunista le sottrasse la licenza. Si veda: http://www.stadtwikidd.de/wiki/Verlag_Wolfgang_Jess
[19] Nello stesso anno la medesima edizione compare anche nella Repubblica Federale Tedesca a cura dell’editore Nymphenburger Verlagsbuchhandlung di Monaco di Baviera. È un fatto assai strano, la cui spiegazione è forse che Uhde-Bernays accetta che la pubblicazione sia fatta a Dresda dall’editore ‘storico’ Wolfgang Jess, ma non vuole limitare la circolazione del libro alla Germania orientale, con cui la Germania Occidentale non aveva alcun rapporto, e pubblica perciò un’edizione parallela anche in occidente.
[20] Guhl, Ernst - Künstler - Briefe. Übersetzt und erläutert, Berlino, Trautwein, 1853. Il testo completo è disponibile all’indirizzo https://archive.org/details/kunstlerbriefe01guhl
[21] Guhl, Ernst - Künstler-Briefe. Band 2, Kunst und Künstler des siebzehnten Jahrhunderts, Berlino, Guttentag, 1856. Il testo completo è disponibile all’indirizzo https://archive.org/details/kunstlerbriefe02guhl.
[22] Si veda la voce "Uhde, August Friedrich Hermann Karl" in: Allgemeine Deutsche Biographie 39 (1895), pagine 140-141. http://www.deutsche-biographie.de/pnd117267457.html?anchor=adb.
[23] Uhde-Bernays, Hermann - Im Lichte der Freiheit, Wiesbaden, Insel Verlag, 1948, 535 pagine. Consultata nella seconda edizione rivista del 1963, a cura dell’editore di Monaco di Baviera Nymphenburger Verlagshandlung (607 pagine)
[24] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 10
[25] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 265
[26] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 366
[27] Uhde-Bernays Hermann, Mein weißes Haus, citato.
[28] La seconda edizione, da me consultata, viene terminata nel 1958 e pubblicata nel 1963.
[29] Si veda Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7 marzo 1964, http://www.gbv.de/dms/faz-rez/640307_FAZ_0081_BuZ5_0001.pdf.
[30] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 582.
[31] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 9.
[32] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 428.
[33] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 264.
[34] Uhde-Bernays Hermann, Künstlerbriefe über Kunst, … (citato), p. 9
[35] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 203
[36] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 263
[37] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), pp. 385-386
[38] Rispetto agli sviluppi francesi l’ingresso degli impressionisti è molto tardo, ed avviene quando il movimento artistico a Parigi si è già esaurito ed è stato già sostituito dalle correnti post-impressioniste. A Berlino gli impressionisti entrano solamente nel 1898-1899, addirittura dopo le prime incursioni delle avanguardie con la mostra di Munch, subito proibita, organizzata da Walter Leistikow a Berlino nel 1892. Uhde-Bernays è testimone sia della presenza di Munch, Hamsun e Przybyszewki – artisti e letterati maledetti – nei circoli simbolisti di artisti e letterati (“tutti e tre alcolizzati, poverissimi, spesso senza alcuna idea di come tirare a campare il giorno dopo, e tuttavia decisi a non fare alcuna concessione ai borghesi”, si veda p. 216 di Im Lichte der Freiheit) sia del contemporaneo successo commerciale degli impressionisti nella borghesia della capitale tedesca grazie ai fratelli Cassirer.
[39] L’originale è disponibile all’indirizzo https://archive.org/details/derfallbcklinun00meiegoog
[40] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 361
[41] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 381
[42] Uhde-Bernays, Im Lichte der Freiheit, citato (…), p. 427
[43] Si veda: Meier-Graefe, Julius - Kunst ist nicht für Kunstgeschichte da: Briefe und Dokumente, Gottinga, Wallstein Verlag, 2001, 574 pagine. Citazione alle pp. 426-426. I firmatari sono: Peter Behrens, Theodor Behrens, Oskar Bie, Eberhard Freiherr von Bodenhausen-Degener, Hugo Bruckmann, Lovis Corinth, Richard Dehmel, Walther Epstein, Paul Fechter, H.A. Graf Harrach, Kurt Herrmann, Adolf von Hildebrand, Hugo von Hofmannsthal, Georg Kolbe, Leo Freiherr von König, H.E. Lind-Walther, Julius Levin, Kurt Freiherr von Mutzenbecher, Karl Ernst Osthaus, Gustav Pauli, Hermann vom Rath, R.A. Schröder, Eugen Spiro, Georg Swarzenski, Louis Tuallon, H. Uhde-Bernays, Lutz Wolde, Heinrich Wölfflin.
[44] L’originale è disponibile all’indirizzo https://archive.org/details/carlspitzwegdesm00uhdeuoft.
[45] L’originale è disponibile all’indirizzo: https://archive.org/details/mnchenerlandsc00uhdeuoft.
[46] Oldenbourg, Rudolf e Uhde-Bernays, Hermann - Die Münchner Malerei im neunzehnten Jahrhundert. Teil I: Die Epoche Max Josephs und Ludwigs I. II.Teil: 1850-1900. Mit zahlreichen Abbildungen im Text. Monaco, Verlag F. Bruckmann A.-G., 1922, pagine 302 e 303.
https://letteraturaartistica.blogspot.com/2015/11/gottfried-semper.html
Nessun commento:
Posta un commento