English Version
Gli insegnamenti della pittura del giardino grande come un granello di senape.
Chieh Tzǔ Yüan Hua Chuan
A cura di Mai-Mai Sze
Traduzione italiana di Riccardo Mainardi
Milano, Luni editrice, 2017
Recensione di Giovanni Mazzaferro
 |
| La copertina dell'edizione Luni (2017) |
Premessa
Gli insegnamenti della pittura del giardino grande come un granello di
senape sono uno dei più famosi e diffusi manuali cinesi di pittura. La
prima edizione fu pubblicata nel 1679 e da allora ne sono uscite almeno una
ventina di edizioni. Mi pare indispensabile, tuttavia, fare chiarezza innanzi
tutto in merito alla presente, pubblicata da Luni a fine 2017. Si tratta di una
versione a cura di Mai-Mai Sze (1909-1992), figura di artista e scrittrice
cinese vissuta in realtà quasi sempre in Occidente. Mai-Mai era figlia
dell’ambasciatore cinese in Inghilterra e lì visse dal 1915 al 1921,
trasferendosi col padre negli Stati Uniti quando quest’ultimo divenne
ambasciatore in America. La sua traduzione inglese del Chieh Tzǔ Yüan Hua Chuan (questo il titolo originale dell’opera)
risale addirittura al 1956 e numerose furono le ristampe successive [1]. Nel 1989
Riccardo Mainardi tradusse in italiano la versione inglese (non operò quindi
direttamente dal cinese) di Mai-Mai, pubblicando con la milanese Leonardo editrice Gli
insegnamenti della pittura del giardino grande come un granello di senape. Enciclopedia della pittura cinese. Questa traduzione, risalente appunto al 1989, viene ora ristampata da Luni,
senza, tuttavia che nulla di tutto ciò sia spiegato. Intendiamoci, i nomi della
curatrice e del traduttore compaiono in frontespizio e a p. 6 l’editore chiarisce
che “ha cercato con tutte le sue
possibilità di rintracciare il Traduttore della presente opera. L’Editore si
dichiara pronto a far fronte al pagamento dei diritti d’autore secondo le
convenzioni del diritto d’autore agli aventi diritto”. Un minimo di
contestualizzazione storica, tuttavia, non avrebbe fatto male, se non altro
perché il lettore, scorrendo l’introduzione di Mai-Mai Sze si trova di fronte a
frasi del tipo “come sanno tutti coloro
che abbiano tradotto dal cinese in inglese, capita spesso che la traduzione
letterale della frase cinese dia luogo in inglese a una sequela di parole senza
senso” (p. 11) e, ovviamente, si sente disorientato.
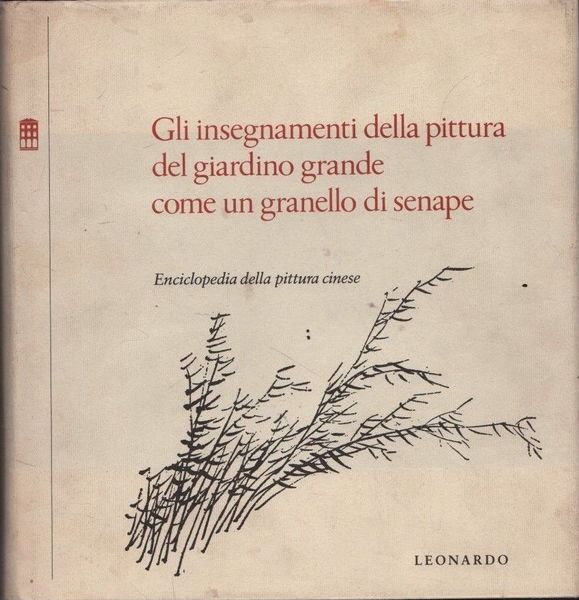 |
| La copertina dell'edizione Leonardo (1989) |
Un manuale di pittura
Il Giardino grande come un granello di senape – diciamolo subito –
molto probabilmente indica un luogo, ovvero il giardino della villa di Nanchino
che era l’abitazione di Li Yü, editore della prima versione
dell’opera, pubblicata nel 1679. Tale edizione era composta in origine di una
sola parte, contenente cinque libri. Solo il primo era unicamente di testo, e
conteneva i ‘principi generali’ dell’arte, mentre i successivi si occupavano
rispettivamente delle modalità per dipingere gli alberi (II), le rocce (III),
le persone e le cose (IV), e l’ultimo presentava esempi supplementari di
pittura di paesaggio. Nel 1701 lo stesso editore pubblicò una seconda versione
degli Insegnamenti, fortemente ampliata e, questa volta, scandita in tre parti.
Oltre alla prima, la seconda conteneva il Libro
dell’orchidea, il Libro del bambù,
il Libro del pruno e il Libro del crisantemo. La terza
consisteva invece di due Libri destinati rispettivamente a erbe, insetti e
piante fiorifere (il primo) e a piume, pellicce e (altre) piante fiorifere (il secondo). Vi
erano poi, a completamento della terza parte, due libri ulteriori di esempi
illustrati. Questa è, in sostanza, la struttura ‘classica’ del manuale a cui,
nel 1818, fu aggiunta una quarta parte, che ovviamente non aveva nulla a che
fare con editore e autori originari. Proprio di autori, a questo punto, dobbiamo
parlare: si tratta dei tre fratelli Wang. Wang Kai fu “il coordinatore generale dell’opera e l’unico autore della prima parte,
di cui apprestò anche l’apparato illustrativo, un compito che richiese tre anni
di lavoro” (p. 8). L’edizione del 1679, in sostanza, è quindi scritta da
Wang Kai (che nell’opera si presenta con lo pseudonimo di Lu Ch’ai), con una
prefazione dell’editore, ovvero di Li Yü. Wang Shih e Wang Nieh, invece,
ovvero i due fratelli di Wang Kai sembrano essersi occupati delle parti seconda
e terza che furono aggiunte nel 1701, anche perché specializzati nella pittura
di fiori e di uccelli.
Il grande pregio del manuale (e
anche il motivo per cui ebbe successo così prolungato) è il suo ricchissimo
apparato iconografico, in cui si illustravano i diversi modi di dipingere
alberi, rocce etc propri dei pittori vissuti nei secoli precedenti. È
indubbio che, da un punto di vista teorico, gli Insegnamenti non apportino novità. Scrive in merito Mai-Mai Sze: “Il contenuto del manuale e il suo
atteggiamento nei confronti della pittura si basano su concetti e dottrine da
tempo patrimonio di questa tradizione di pensiero, di usanza e di condotta
rituale. Non a caso molti passaggi in esso menzionati sono espunti direttamente
da opere fondamentali di epoche precedenti […] Occorre spiegare come fosse
pratica corrente incorporare negli scritti e nelle compilazioni cinesi frasi,
massime e lunghi passaggi senza necessariamente precisarne la fonte. Si ritiene
infatti che tali citazioni si situino al servizio della tradizione, servano,
cioè, a tramandarla e – tramandandola – a mantenerla e a rafforzarla” (p.
9). Non deve sorprendere, dunque, che, nonostante la loro fortuna editoriale,
gli Insegnamenti non compaiano nella
celebre antologia di Lin Yutang sulla Teoria
cinese dell’arte. Yutang scrive infatti che i trattati di pittura
cinese, in linea di massima, dicono tutti le stesse cose, attenendosi alla
tradizione, e che per la sua antologia ha scelto testi storicamente importanti,
cercando comunque di evitare ripetizioni ed evidenziando gli aspetti
innovativi. Così, ad esempio, i Sei
Canoni della pittura, che negli Insegnamenti
compaiono nel Libro primo (p. 32) risalgono in realtà almeno al V secolo dopo
Cristo.
 |
| Insegnamenti della pittura del giardino grande come un granello di senape. Libro II: una tavola per imparare la pittura delle foglie Fonte: Wikimedia Commons |
 |
| Insegnamenti della pittura del giardino grande come un granello di senape. Libro III: insegnamento della pittura dei personaggi Fonte: Wikimedia Commons |
L’importanza degli Insegnamenti
Il fatto che gli Insegnamenti non presentino elementi di
particolare novità non vuol dire, tuttavia, che non abbiano una loro
importanza, al di là della straordinaria ricchezza del loro apparato
iconografico. Storicamente, il manuale viene pubblicato appena qualche decennio
dopo la caduta della dinastia cinese Ming (1644) e l’arrivo di quella Manchu
Ch’ing (di origini straniere). Il manuale può essere interpretato dunque come uno
scritto ‘identitario’, in cui viene presentato il sapere sviluppato nei secoli
precedenti: “esso [il manuale] rappresenta la ricapitolazione dei criteri
stabiliti nell’epoca d’oro dell’arte pittorica cinese; e, specificandone i
principi e gli aspetti tecnici di base, tramanda i tratti più salienti del tao
[la ‘strada per eccellenza’] della pittura. […] Esso ci offre una visione delle altezze raggiunte dalla pittura cinese,
muovendo da un periodo immediatamente successivo a quelli della più alta
creatività e compendiandone gli aspetti permanenti e durevoli” (p. 10).
 |
| Anonimo, Nespolo e uccello di montagna, Dinastia Song (1127-1279) Fonte: http://depts.washington.edu/chinaciv/painting/4courbf.htm |
Alcuni aspetti della pittura cinese
Naturalmente, studiare la pittura
cinese vuol dire abbandonare molti dei canoni con cui siamo abituati a parlare
di arte noi occidentali. Non sarei certo in grado di darne un’idea completa e
corretta. Mi piace, tuttavia, l’idea di segnalare alcuni aspetti che da un lato
sembrano suggerire un parallelo con la pittura occidentale e che però,
dall’altro, si rivelano ben presto discordanti. Il primo, banalissimo, è che
quando parliamo di pittura, in Occidente, almeno dal 1500 in poi, parliamo in
linea di massima di quadri; mentre nel caso cinese s’intendono opere d’arte
eseguite su rotoli o su album. Esiste proprio una diversa fisicità che riguarda
non solo la presentazione dell’opera, ma anche i supporti stessi (quasi sempre
si dipinge su sete o su carta, non su tela).
L’altra grande differenza è che
la pittura cinese è, molto prima di quella occidentale e di fatto per più di un
millennio, pittura di paesaggio. Esiste, insomma, uno scarto enorme. In Europa
il genere artistico per eccellenza è la pittura di storia e quella di paesaggio
è relegata a genere minore; in Cina le cose stanno esattamente all’opposto,
tanto che la presenza antropica è oggetto di un Libro ad hoc del manuale, e
nemmeno il primo, ma il terzo, dopo quello degli alberi e delle rocce, ben più
importanti. Riporto in merito uno stralcio di quanto si può leggere nella
bandella del libro: “Nella tradizione
dell’antica Cina, l’armonia di un prodotto artistico rispecchia l’armonia
universale del Tao, il supremo e imperscrutabile Principio che ha generato il
mondo e governa il ritmo segreto della natura. Non è un caso che il tema
dominante della grande pittura cinese sia il paesaggio, che è sempre
sottilmente realistico e al tempo stesso metaforico. Le figure umane e le opere
dell’uomo non distolgono mai lo sguardo dagli elementi centrali del dipinto:
una montagna, una cascata, un albero, un bambù, un’orchidea. La loro
collocazione stabilisce un clima di corrispondenza simboliche e per analogia
rimanda agli equilibri stabiliti dal Tao tra Cielo e Terra, uomo e natura,
gravità e leggerezza, pieno e vuoto, yin e yang. In ogni cosa vivente o
inanimata circola il Ch’i, l’energia
universale, una forza impalpabile”. Realismo e metafora: la pittura cinese
è ‘naturale’, ma declina tale qualità in maniera diversa da quella intesa in
Occidente. Si pensi ad esempio a quanto si legge nel manuale all’inizio del Libro sulle rocce (col termine roccia si
intende il singolo masso, ma per estensione le montagne): “Quando giudichiamo il valore di una persona, la qualità del suo
spirito (ch’i) ha un valore
altrettanto fondamentale del suo aspetto fisico. Lo stesso si dica delle rocce,
che sono la struttura portante dei cieli e della terra, e parimenti hanno ch’i […]. Le rocce prive di ch’i sono rocce morte, esattamente come le ossa,
prive dello stesso spirito vivificante, sono ossa nude, aride, inerti. […]
Occorre evitare tassativamente di dipingere rocce senza ch’i. Per dipingere rocce che hanno ch’i bisogna spingere la propria ricerca al di
là di ciò che è materiale e nell’ambito dell’intangibile. […] Se la forma della
roccia non sarà chiaramente impressa nel cuore-mente dell’individuo, e pertanto
sulla punta delle dita […] il dipinto non potrà mai giungere a pieno
compimento” (p. 135).
 |
| Shen Zhou, Leggendo nel paesaggio autunnale, XV secolo, Pechino, Palace Museum Fonte: Wikimedia Commons |
Cuore, mano, pennello e inchiostro
Cuore-mente e punta delle dita,
si è detto poca fa. L’armonia fra cuore e mano dell’artista è un prerequisito
per dipingere bene. Ma non si finisce con la mano. In tutta la pittura cinese
ha un ruolo fondamentale l’uso del pennello. Basta consultare il Libro primo (quello con le disposizioni
generali) per capire quanto sia importante il ruolo del pennello nell’arte
cinese. Non ci troviamo di fronte a un semplice oggetto, ma a un’estensione
della mano, e quindi del cuore-mente. La maggior parte delle prescrizioni
riguarda appunto le modalità di pennellata dei grandi maestri. E l’estensore
dell’opera si preoccupa di consigliare al dilettante l’imitazione della
pennellata di questi maestri. Solo dopo aver raggiunto la perfetta armonia fra
cuore e mano, l’artista potrà “plasmare
così ogni sorta di pennellata, di tutte le scuole che crede, e in ogni
proporzione. […] In questo stadio più avanzato è bene dimenticare le
classificazioni ed elaborare le pennellate secondo le proprie combinazioni.
Tuttavia, nella fase iniziale non bisogna mescolare le varie pennellate”.
Credo di poter dire che questa particolare enfasi sulla manualità del gesto (e
sul significato simbolico che corrisponde alle varie tecniche) marchi una netta
differenza rispetto alla teoria artistica occidentale, in cui invece, almeno
dal Cinquecento in poi le discussioni sulla ‘nobiltà’ della pittura rischiano
di far passare in secondo piano gli aspetti pratici del mestiere.
In simbiosi col pennello troviamo
l’utilizzo dell’inchiostro. La pittura cinese è una pittura innanzi tutto a
inchiostro. Sono le tonalità dell’inchiostro a organizzare la composizione, le
sue sfumature “a distinguere ciò che è
vicino da ciò che è distante, le nubi dai riflessi, la luce dall’ombra” (p.
37), tanto che calligrafia e pittura vengono, di fatto, a coincidere: “non vi è differenza alcuna fra la tecnica
del pennello applicata alla calligrafia o alla pittura: l’una e l’altra esigono
lo stesso tipo di approccio” (p. 38). Il colore, in questo ambito, ha un
ruolo importante, ma secondario, e viene sempre dopo l’inchiostro, con chiari
scopi funzionali: “Per dipingere i giochi
di luce e d’ombra delle foreste, gli spigoli e le fenditure nelle rocce sui
monti e le varie tonalità d’ombra nelle gole e nelle forre occorre mescolare
l’inchiostro ai colori. In tal modo le gradazioni di colore risulteranno
nitide, e la profondità e le dimensioni risulteranno nettamente evidenziate”
(p. 47).
 |
| Mi Fei, Montagne e pini in primavera, XII secolo, Taipei, National Palace Museum Fonte: The Yorck Project tramite Wikimedia Commons |
 |
| Li Cheng, Tempio Buddhista fra le montagne, X sec. d.C. Fonte: http://www.seattlecentral.org/faculty/cmalody/T3ma/chland8-10.htm |
Una gerarchia di pittori
L’armonia fra cuore e pennello,
la padronanza delle tecniche, il tipo di pennellata usata, la vitalità impressa
nella rappresentazione del paesaggio sono, in ultima analisi, le qualità che
definiscono il grande artista. Quando tale vitalità opera attraverso il
pittore, “l’effetto nella sua pittura è
al di là di ogni possibile definizione, ed è possibile dire che il pittore
appartiene alla classe shên
(divina)” (p. 33). Sarei in realtà curioso di capire meglio come e in che
misura questa ‘divinità’ si distingua da quella del divin Raffaello di casa
nostra o, ancora, da quella nutrita di profonda religiosità che
tradizionalmente è stata abbinata ad alcune figure di pittori particolarmente
devoti, e come tali capaci di produrre immagini miracolose (si pensi alla
tradizione delle Madonne di Lippo di Dalmasio). Qui sembra che l’attributo
della divinità serva a costruire una classifica di merito, se è vero che subito
dopo si specifica che, un gradino più in basso, “quando la tecnica del pennello è elevata, i colori sono appropriati e
l’espressione è chiara e armoniosa, il pittore può essere incluso nella classe miao (meravigliosa e profonda). Quando la forma
è stata realizzata e le regole sono state applicate, il pittore rientra nella
classe nêng (abile e compiuta)” (ibidem): una
distinzione che, diremmo oggi, mira a specificare quali siano le differenze fra
il grandissimo artista e il mero artefice.
NOTE
Nessun commento:
Posta un commento