English Version
Pietro Selvatico e il rinnovamento delle arti nell’Italia dell’Ottocento
A cura di Alexander Auf der Heyde, Martina Visentin e Francesca Castellani
Pisa, Edizioni della Normale, 2016
Recensione di Giovanni Mazzaferro
 |
Il volume raccoglie gli atti del
convegno di studi dedicato a Pietro Selvatico, tenutosi all’Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti il 22 e 23 ottobre 2013 e va inserito in un processo
di rivalutazione della figura del marchese padovano che negli ultimi anni ha
visto prima la pubblicazione della ristampa anastatica del suo Sull’educazione del pittore storico odierno
italiano (a cura di Alexander Auf der Heyde, Pisa, Edizioni della Normale,
2007) e poi l’uscita della monografia di Alexander Auf der Heyde Per l’«avvenire dell’arte in Italia»: Pietro Selvatico e l’estetica applicata alle arti del disegno nel secolo XIX (Pisa, Pacini, 2013). Ricordo infine che,
qualche mese dopo gli atti del convegno, sono stati pubblicati i due volumi
dedicati alla storia ottocentesca dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, in
cui, di fatto, Selvatico (col suo decennio ai vertici dell’Accademia, fra 1850
e 1859) appare come il personaggio di svolta dell’Istituto, i cui metodi
didattici erano sino ad allora fondati su un attardato neoclassicismo. Ho già
avuto modo di scrivere a lungo sulla bella monografia del 2013 e, per rispetto
del lettore, non intendo ripetere quanto già detto, rinviando semmai alla lettura della relativa recensione.
Qui vorrei richiamare degli aspetti
ulteriori. Ovviamente, quando a intervenire sono 27 studiosi di estrazioni
anche diverse vi è modo di approfondire argomenti precedentemente tralasciati
(anche per via della sterminata produzione pubblicistica del marchese
patavino). Si pensi, ad esempio, a Selvatico autore di racconti storici (quello
che è stato probabilmente oggetto degli strali più pesanti della critica, coi
suoi testi narrativi che presentano biografie romanzate di artisti famosi). Ne
indaga la strategia comunicativa Massimo Ferretti in Sotto «l’albero dell’arte». Gli artisti del passato fra esempio del bello
visibile e racconto storico. Ma si leggano anche gli interventi di Chiara
Marin su Selvatico pubblicista: gli
interventi sulla stampa periodica lombardo-veneta e di Giovanna D’Amia su La collaborazione con la «Rivista Europea» e
i rapporti con l’ambiente milanese. Non trascurate poi l’importanza del
lavoro svolto da Alexander Auf der Heyde e Martina Visentin ne Gli scritti di Pietro Selvatico: un
censimento bibliografico. Se si tien conto di quanto importante sia stata
per Pietro l’attività di pubblicista si capisce bene quanto fondamentale sia
avere un ‘inventario’ di ciò che scrisse: si tratta di un elenco di centinaia
di contributi (che gli stessi curatori ammettono essere comunque incompleto)
fra cui, a titolo di pura curiosità, io, che di recente mi sto dedicando allo
studio di Vasari, segnalo il commentario e le note alla biografia del Mantegna
nell’edizione delle Vite Le Monnier
in 14 volumi pubblicata fra 1846 e 1870.
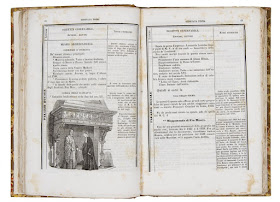 |
| Pietro Selvatico e Vincenzo Lazzari, Guida di Venezia e delle isole circonvicine, 1852 Fonte: http://www.gonnelli.it/uk/auction-0011-1/selvatico-pietro-guida-di-venezia-e-delle-isol.asp |
La
storia di un perdente
Tutto ciò detto, e senza stare a
discutere tutti i contributi presentati nel volume (troverete l’elenco completo
in fondo alla recensione) non posso negare di provare una simpatia del tutto
istintiva nei confronti di Selvatico e ciò per almeno due motivi: perché
comunque si provi è praticamente impossibile incasellarlo dentro a una
qualsiasi etichetta, e poi perché la sua è fondamentalmente la storia di un
perdente, di un uomo che probabilmente fatica ad andare d’accordo con se
stesso, autore di clamorosi voltafaccia (si pensi alla determinazione, dopo
nove anni di Accademia, che in fondo le Accademie è meglio abolirle che
riformarle, in una logica del tanto peggio tanto meglio che mi ricorda
sinistramente tanta parte dell’odierna politica italiana); un uomo che,
sicuramente, sbaglia tempi e modi di intervento ed è sorpassato dalla storia.
Mi ha molto colpito che fra i
ventisette autori dei saggi vi sia chi definisca Selvatico un purista, ma anche
chi distingua fra purismi; chi parli dell’ammirazione nei confronti dei
Nazareni, ma pure chi ricordi che il marchese era contrario a qualsiasi forma
di pedissequa imitazione dei suoi adorati quattrocentisti (e qui la suggestione
che Selvatico avesse quanto meno letto von Rumohr è forte). Insomma, Pietro è
difficile da collocare, e sono personalmente convinto che sia più facile
cercare di capire cosa il marchese non fu: ad esempio, non fu un conoscitore.
Ragghianti lo fulmina dicendo che “debolissimo in lui è il senso nativo
dell’arte, la spontanea aderenza al fatto figurativo per se stesso” (p. 19). E
giustamente Ferretti fa presente che l’estetica di Selvatico fu un’estetica
diversa da quella a cui si riferiva Ragghianti, un’estetica “della produzione”
(p. 22), riferita alle arti guardando ad esse come ‘sistema’ (una sensibilità
che ci è molto più vicina oggi di quanto non sia stato nel secolo scorso e che
spiega – come ricorda Margherita d’Ayala Valva a p. 544 – come mai nessuno più
di lui, lo scorso secolo, sia stato associato mentalmente all’Ottocento
‘stupido’).
A dire il vero ci fu un’altra cosa che
Selvatico (proprio perché non-conoscitore) non fu (sto giudicando sulla base di
quanto letto e non per mie conoscenze personali): non fu un uomo del mercato,
o, meglio, non fu uomo coinvolto nel commercio di quadri antichi per conto di
musei o altri collezionisti italiani o stranieri. Devo dire che mi ha molto
stupito che questo suo non-essere uomo di mercato non sia emerso come elemento
di riflessione negli atti (chiedo venia ai curatori, se mai leggeranno questa
recensione, ma è noto che almeno un difetto a un libro va trovato). Eppure è un
fatto assai inconsueto per quegli anni, in cui operano i Rumohr, i Mündler, gli
Eastlake e poi Morelli e Cavalcaselle (solo quest’ultimo ne fu immune), ma
anche una serie di studiosi italiani che danno alla luce opere di sicuro
successo ed esercitano parallelamente attività mercantile (il caso più
evidente, e mai studiato, è il bolognese Michelangelo Gualandi). Questo non
avere interessi di carattere commerciale lo rende peraltro più credibile quando
si occupa di tutela e di restauro del patrimonio. Che ben altre fossero le
consuetudini in merito emerge peraltro da quanto scritto da Giuseppina Perusini
in Selvatico e il restauro pittorico
a proposito del restauratore Paolo Fabris (pp. 483 ss.) che non disdegnava di
abusare del suo ruolo per fungere da mediatore nella vendita di quadri
all’estero.
Non conoscitore, né uomo di mercato,
tanto meno patriota. Il liberalismo cattolico di cui Selvatico fu portavoce
così convinto fino al 1848 si infranse (come bene ha spiegato Auf der Heyde nel
suo libro del 2013) di fronte a una violenza rivoluzionaria che evidentemente
lo turbò e lo spinse su posizioni reazionarie. Inutile negarlo: la novità e per
molti versi la modernità della sue riforme (effettuate o progettate) in
Accademia furono eclissate dall’accusa di essersi compromesso col governo
austriaco, una nomea che gli rimase attaccata ben oltre la morte. Il corso
degli eventi, ovviamente, non lo favorì. Nel momento in cui l’Italia diveniva unita
e Selvatico avrebbe potuto cercare di imporre i suoi metodi didattici
all’attenzione delle nuove istituzioni, il marchese (allontanatosi
dall’Accademia non per motivi politici, ma perché disgustato per non essere
sostenuto dal governo austriaco nella sua diatriba con Blaas) restava straniero
in quel di Padova altri cinque anni. Nel frattempo (per fare un esempio)
Morelli e Cavalcaselle erano in giro per le Marche a dorso di mulo per cercare
di mappare il patrimonio artistico locale. Finiranno con l’abbaiarsi contro,
l’uno aristocratico e cavouriano, l’altro di umili origini e garibaldino
(nonché repubblicano), ma si legittimeranno entrambi come punti di riferimento
dell’arte italiana. Giustamente Luca Giacomelli fa presente in Selvatico, Giusti e la polemica
sull’insegnamento del disegno che l’annessione del Veneto, nel 1866, “apre
a Selvatico una nuova sfida intellettuale: intervenire da protagonista
nell’organizzazione scolastica del neonato Regno, rendendo applicative su scala
nazionale le sue idee in fatto di educazione” (p. 490). Chiaramente, coi suoi
precedenti politici, il marchese non partiva in posizione di vantaggio.
 |
| Facciata della chiesa di S. Pietro a Trento (realizzata su progetto di Pietro Selvatico) Fonte: Wikimedia |
Selvatico e l’esteromania
Non si può non dedicare qualche parola alla questione dell’esteromania di Pietro Selvatico. Il
marchese, notoriamente, fu accusato ai suoi tempi di essere un fanatico di
tutto ciò che avveniva oltre confine, e di sacrificare gusto e tradizione
italiani a vantaggio di modelli stranieri. L’accusa è – ovviamente – una
sciocchezza, ma, trovandoci in quell’epoca negli anni costitutivi di molte
realtà nazionali fu presa sul serio. Quadrava bene, fra l’altro, con la nomea
di essere una spia degli austriaci. Selvatico fu invece un uomo che si tenne
aggiornato sul dibattito sulle arti, sulla rivalutazione del Medio Evo, e
soprattutto sull’utilizzo di sistemi didattici nelle Accademie non italiane. Un’intera
sezione del volume è dedicata ad esplorare tali aspetti: a giocare un ruolo
preponderante furono gli sviluppi francesi (anche per una questione linguistica:
la madre era francese) e quelli tedeschi. Sono particolarmente intriganti
tuttavia le pagine che Donata Levi dedica alle interazioni col mondo culturale
inglese in Selvatico e la cultura
inglese: labili tracce tra indifferenza e omissioni, non tanto perché tali
tracce siano numerose, ma perché, al di là della reciproca indifferenza formale
fra le parti, tradiscono un comune sentire, che è quello della riscoperta del
Medio Evo e del gotico. Se nel caso di Selvatico e Pugin ci si deve
oggettivamente limitare a rilevare due percorsi che camminano in parallelo,
talvolta si avvicinano, ma mai si incontrano, il discorso diventa diverso
quando prendiamo in considerazione Ruskin.
A dispetto di una sostanziale
indifferenza dimostrata dal critico inglese nei confronti di Selvatico ne Le pietre di Venezia (pubblicato in tre
volumi tra 1851 e 1853), la realtà appare oggi ben diversa. Dall’esame dei
cosiddetti “taccuini veneziani” e di altri materiali preparatori dell’opera (in
particolare un altro taccuino conservato alla Bodleian Library di Oxford)
emerge chiaro che l’inglese si confronta assai spesso con la “guida estetica”
pubblicata da Selvatico nel 1847 (Sulla
architettura e sulla scultura in Venezia dal medio Evo sino ai nostri giorni),
testimoniando quel “corpo a corpo che Ruskin sempre ingaggia o con gli autori
che più assiduamente frequenta o con quelli che comunque più lo intrigano… Il
testo viene indagato, quasi smontato e ricomposto in un’operazione dettata
dall’esigenza di un costante e puntuale riscontro sul campo, sul corpo
dell’edificio o sui documenti originali” (p. 268). Sono pagine da leggere con
attenzione, in cui Ruskin è attratto dalla periodizzazione degli edifici
veneziani dalle origini al 1500 fornita da Selvatico, e finisce sostanzialmente
per aderirvi, e in cui il marchese non appare certo come l’acritico plagiatore
di qualsiasi “moda” straniera, quanto piuttosto un uomo inserito in un circuito
europeo e che, nell’ambito di tale circuito, contribuisce al dibattito.
Indice
Ecco, infine, l’indice dei contributi
raccolti nel volume:
Alexander Auf der Heyde, Martina
Visentin, Francesca Castellani, Introduzione
Biografia,
storiografia ed estetica nel pensiero di Selvatico
- Massimo Ferretti, Sotto «l’albero dell’arte». Gli artisti del passato fra esempio del bello visibile e racconto storico.
- Franco Bernabei, Modelli storiografici e critici in Selvatico.
Scienziato
nell’ambiente erudito veneto
- Michele Simonetto, Pietro Selvatico e l’agricoltura come reggimento civile delle città.
- Giuseppe Gullino, Selvatico e l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
Pubblicista
e critico militante
- Chiara Marin, Selvatico pubblicista: gli interventi sulla stampa periodica lombardo-veneta.
- Giovanna D’Amia, La collaborazione con la «Rivista Europea» e i rapporti con l’ambiente milanese.
- Alfredo Cottignoli, Selvatico e Tenca: due critici d’arte a confronto.
Esterofilo
e agente del transfer culturale
- Tiziana Serena, Selvatico, l’ “esteromania” e la fotografia: alcune aggiunte.
- Alexander Auf der Heyde. I rapporti con Vienna: Selvatico, l’abate Pietro Mugna e Rudolf Eitelberger von Edelberg.
- Rossella Fabiani. Pietro Selvatico nelle lettere a Pietro Nobile;
- Martina Visentin, Sui contatti di Selvatico con la contemporanea storiografia francese: Rio e Montalembert.
- Donata Levi, Selvatico e la cultura inglese: labili tracce tra indifferenza e omissioni.
Storico
dell’architettura e conservatore dei monumenti
- Guido Zucconi, Per una scienza dei monumenti architettonici.
- Xaxier Barral i Altet, Il dibattito in Francia sull’architettura medievale al tempo di Pietro Selvatico (1803-1880).
- Antonella Ballardini, Selvatico e gli studi dedicati a S. Marco.
- Isabella Collavizza, L’istituzione della Commissione per la conservazione dei monumenti delle province venete.
- Elisabetta Concina, Considerazioni sui Monumenti artistici e storici delle province venete di Pietro Selvatico e Cesare Foucard.
Riformatore
della didattica a Venezia e a Padova
- Rosa Tamborrino, Imparare l’architettura a Venezia secondo Pietro Selvatico: la formazione tra impegno civile, sperimentazione e conoscenza storica di una bellezza visibile.
- Antonella Bellin, Elena Catra, L’Accademia di Belle Arti di Venezia e la riforma di Pietro Selvatico (1849-59)
- Maria Ida Biggi, Pietro Selvatico e la Commissione Artistica governativa per gli spettacoli al Teatro La Fenice.
- Giuseppina Perusini, Selvatico e il restauro pittorico.
- Luca Giacomelli, Selvatico, Giusti e la polemica sull’insegnamento del disegno.
Progettista
tra teoria e prassi
- Francesca Castellani, La basilica di transizione. Selvatico e il Santo: dal monumento al progetto, dalla didattica al cantiere.
- Vincenzo Fontana, Dalla teoria alla pratica. La cappella Pisani a Vescovana.
Scrittore
d’arte e modello per gli artisti
- Margherita d’Ayala Valva, L’artista lettore, la tecnica, la scrittura. Morbelli legge Selvatico.
Strumenti
- Tiziana Serena, La biblioteca d’arte di Pietro Selvatico Estense.
- Alexander Auf der Heyde, Martina Visentin, Gli scritti di Pietro Selvatico: un censimento bibliografico.
Nessun commento:
Posta un commento