English Version
[N.B.: Su Giorgio Vasari si veda in
questo blog anche: Giovanni Mazzaferro, Una
copia delle Vite giuntine (1568) posseduta da Marcantonio Vasari e custodita in
Fondazione Cavallini Sgarbi; Giovanni Mazzaferro, Un
‘nuovo’ ritratto di Correggio in un esemplare delle Vite vasariane all’asta
presso Sotheby’s; Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori,
scultori e architettori. Edizione diretta da Enrico Mattioda. Parte Prima,
Seconda
e Terza;
Giovanni Mazzaferro, Gli esemplari postillati delle Vite vasariane: un
censimento. Parte Prima e Seconda;
Marco Ruffini, Postille
padovane del 16° secolo in una prima edizione delle Vite vasariane (1550); Giovanni
Mazzaferro, Ancora
un nuovo esemplare postillato delle Vite vasariane: l’Anonimo della Biblioteca
Marciana di Venezia; Giovanni Mazzaferro, Ritratti disegnati a mano nelle
Vite del Vasari: nuove scoperte. Parte
Prima e Seconda;
Lucia Collavo, L'esemplare
dell'edizione giuntina de Le Vite di Giorgio Vasari letto e annotato da
Vincenzo Scamozzi; Le
'Vite tascabili' di Giorgio Vasari: intervista ad Alessandro Nova, curatore
della collana; Giovanni Mazzaferro, Gli
esemplari postillati delle Vite vasariane: un censimento; Giovanni
Mazzaferro, Vasari
e la ‘Questione omerica’: opposte interpretazioni delle Vite alla luce della
biografia di Leonardo da Vinci; Barbara Agosti, Giorgio
Vasari. Luoghi e tempi delle Vite.]
Undici anni, dal 2004 al 2015, sono serviti all’editore berlinese Wagenbach per proporre al pubblico la nuova edizione in lingua tedesca delle Vite del Vasari (con una traduzione inedita dopo oltre cent’anni dalla precedente). Ma l’elemento che senza dubbio ha caratterizzato l’impresa editoriale consiste nel fatto che le Vite sono state “spezzate” in singoli volumi di dimensioni tascabili. Ne sono stati sfornati 45 (l’ultimo, dedicato a Giotto, è del settembre 2015). Ognuno di essi presenta i singoli medaglioni (o, in alcuni casi, gruppi di biografie) degli artisti trattati dal Vasari e si presenta con una veste particolarmente piacevole: si apre con una breve presentazione, il testo della traduzione tedesca (a essere utilizzata è la versione Giuntina del 1568, ma sono segnalate le varianti rispetto alla Torrentiniana del 1550), l’apparato delle note, l’indicazione della collocazione attuale delle opere individuate, un corpus iconografico essenziale e la bibliografia.
Così Giorgio Vasari è stato l’italiano più gettonato alla recentissima Fiera del Libro di Francoforte. La conclusione della collana è stata recensita anche sul Corriere della Sera. Potete leggere l’articolo di Ranieri Polese cliccando qui sopra.
Ci è parso interessante, in occasione della conclusione della collana (e in sostanziale contemporanea con lo svolgimento di un convegno dedicato all’opera tenutosi al Bode Museum di Berlino il 7 ottobre 2015) intervistare Alessandro Nova, che della collana stessa è il curatore. Nova – lo ricordiamo – è direttore esecutivo del Kunsthistorisches Institut – Max Planck Institut di Firenze.
D - Gentilissimo Professore, come è nata l’idea di una nuova edizione in tedesco del Vasari? E perché avete scelto di proporla in 45 volumetti?
Dopo aver insegnato a Stanford in California per quasi otto anni, mi sono trasferito a Francoforte sul Meno per motivi familiari nel 1994. Qui avevo vinto il concorso per la sola cattedra della Germania dedicata in modo specifico all’arte del Rinascimento italiano. La didattica è molto importante in Germania e i professori insegnavano dalle otto alle dieci ore alla settimana, per un totale di 240 (a volte 270) ore l’anno. Il tempo per la ricerca era limitato e allora ho pensato di condividere un corso-progetto con gli studenti, anche perché avevo notato che la conoscenza della lingua italiana, un tempo obbligatoria per chi studiava storia dell’arte, non era più adeguata al livello degli studi universitari. Con un piccolo gruppo ho iniziato a tradurre le vite di Leonardo, Giorgione e Correggio, l’inizio della maniera moderna, anche perché, in questi casi, le differenze tra la prima e la seconda edizione sono notevoli e la Torrentiniana (1550) non era stata tradotta in tedesco (né è mai stata tradotta in nessuna altra lingua se non in portoghese).
Abbiamo pubblicato quelle tre vite con l’editore Olms e con l’aiuto della DFG (il CNR tedesco) che per due anni ha finanziato con borse di studio le tesi di laurea degli studenti. Dopo si è sviluppata l’idea di tradurre tutta la terza parte delle Vite, dotandola di un glossario e di un commento su tutte le persone e le opere citate, poiché questo commento era rimasto incompiuto nell’edizione italiana del testo [n.d.r. l’edizione Bettarini-Barocchi]. Si è così passati dai risultati di un piccolo seminario a un progetto di dimensioni notevoli.
Perché pubblicare l’opera in numerosi volumetti? Questo è l’aspetto più criticabile della nostra edizione. Le Vite vanno viste sempre come un tutto indivisibile e questo ho insegnato ai miei studenti: mai perdere di vista la complessità, compattezza e completezza delle due edizioni. Si trattava però di un programma enorme che ci ha occupato per undici anni, anche perché l’editore tedesco, Klaus Wagenbach, nel frattempo ci aveva chiesto di tradurre e commentare tutte le Vite del 1568, non solo quelle della terza parte. Ho compreso subito che non avrei potuto chiedere ai miei studenti, che dovevano laurearsi e al contempo lavorare, un sacrificio così grande senza avere un riscontro del lavoro fatto. In tutto questo tempo abbiamo prodotto 8800 pagine: pensa che qualcuno mi avrebbe seguito se non avessi potuto offrire loro qualcosa di concreto? E chi avrebbe pubblicato il “mostro” alla fine di un lavoro durato anni? I piccoli volumi eleganti e illustrati hanno incontrato un notevole successo di pubblico e hanno motivato ulteriormente gli studenti. Viaggiamo sulle 70.000 copie vendute circa e questo è un segnale importante per il futuro della storia dell’arte italiana in Germania. Per quanto concerne la necessaria unità filologica del testo, ci rifaremo con l’edizione del 1550 che apparirà tra qualche anno, sempre da Wagenbach, in un solo volume. Ma ormai i miei giovani amici hanno fatto quasi tutti “carriera” e possono attendere con maggiore rilassatezza il risultato finale.
D - Chi ha formato il gruppo di lavoro che ha curato le singole biografie?
Il gruppo iniziale era composto da un numero ristretto di studenti: prima di tutti Sabine Feser e Victoria Lorini, che è poi diventata la traduttrice ufficiale delle Vite. Potremmo definirlo il gruppo DFG-Olms, cui si sono aggiunti quasi subito alcuni studenti brillanti come Katja Burzer, Matteo Burioni e Hana Gründler che sono stati presto promossi a co-editori dell’opera. Alla fine del lavoro siamo stati affiancati da Fabian Jonietz, ma tanti altri studenti francofortesi hanno commentato singole vite. Con il passare degli anni, il mio ruolo è diminuito; sono un esperto dell’arte del Cinquecento, ma non ho un controllo totale sulla bibliografia dedicata all’arte del Trecento e del Quattrocento. Non ero più in grado di correggere con assoluta competenza i testi degli studenti e pertanto mi sono rivolto a specialisti degli artisti. Per esempio, il commento alla vita di Donatello è stato scritto da Ulrich Pfisterer, cattedratico dell’università di Monaco di Baviera e grande esperto dello scultore. Mi ha fatto molto piacere constatare come parecchi colleghi universitari fossero pronti a partecipare all’impresa. Ciò confermava la bontà del lavoro svolto sino ad allora. Tuttavia, il gruppo originario è responsabile per il 90% del commento.
D - Come avete affrontato la traduzione dell’opera? Avete scelto una traduzione che rimanesse la più letterale possibile rispetto all’originale o una che in qualche modo ‘rinfrescasse’ la lingua vasariana?
Sin dall’inizio ho chiesto ai miei studenti di restare fedeli alla struttura linguistica delle Vite, rispettando le ripetizioni e persino ridondanze del testo. Una traduzione non può mai essere identica all’originale, ma ci siamo sforzati di rispettare la lunghezza dei paragrafi vasariani e di tradurre il suo testo quasi parola per parola. In questo sforzo ci siamo a volte imbattuti in frasi che non avevano un chiaro significato grammaticale; anche in questi casi non abbiamo cercato di forzare la traduzione interpretando liberamente il pensiero vasariano, bensì abbiamo rispettato l’incongruenza del testo segnalandola in nota.
D - Qual è secondo lei il valore letterario delle biografie vasariane?
Ho sempre cercato di trasmetter ai miei studenti questo messaggio: le Vite di Vasari sono un’opera di letteratura e non solo una “fonte” per le arti visive. Molti dei proemi e la conclusione delle Vite fanno riferimento a questo aspetto e credo che si debba leggere il capolavoro vasariano all’interno dei dibattiti sorti intorno alla questione della lingua.
D - Esiste secondo voi oggi in Italia un problema di fruizione delle Vite di Vasari? Quanto è realistico pensare a un’operazione simile alla vostra anche per i lettori italiani?
Naturalmente il lettore italiano può contare sull’edizione completa delle opere a cura di Paola Barocchi nonché sull’edizione della Torrentiniana a cura di Luciano Bellosi e Aldo Rossi, pubblicata da Einaudi nei Millenni. In Italia le Vite sono ritornate di moda e ci sono tanti storici dell’arte, tra cui Barbara Agosti e Silvia Ginzburg con cui abbiamo organizzato un convegno sulla prima edizione delle Vite al Kunsthistorisches Institut di Firenze oppure Massimiliano Rossi, che studiano il testo vasariano in profondità. Tuttavia, non credo che una nuova edizione delle Vite sia necessaria, almeno oggi.
D - Dal punto di vista editoriale, chi è il lettore tipo al quale vi siete rivolti? È cambiato nel corso degli undici anni? Sapete chi legge Vasari all’inizio del XXI secolo?
Il lettore tipo è lo studente universitario e non è cambiato nel corso degli undici anni. Si spera che i colleghi leggano l’originale… Ma so per certo che molti nostri volumetti, penso per esempio al bellissimo commento di Hana Gründler alla vita di Raffaello, sono spesso consultati dai docenti, anche per preparare articoli scientifici. Per l’editore Wagenbach era poi essenziale raggiungere un pubblico più vasto e crediamo di esserci riusciti, come confermano i dati confortanti delle vendite.
D - Vi è stata una diversa prospettiva storiografica tedesca nella lettura di Vasari nel corso dei secoli, rispetto a quella italiana?
Il grande volume di Wolfgang Kallab, Vasaristudien (1908), ha aperto gli studi moderni dedicati alle Vite nel contesto dell’attenzione della cosiddetta Wiener Schule alle “fonti” della storia dell’arte, ma Julius von Schlosser preferiva, a ragione, parlare di Kunstliteratur. Il libro di Kallab, che abbiamo onorato con un convegno dedicato alle Vite del Vasari al Kunsthistorisches Institut di Firenze nel 2008, è stato recepito dalla migliore storiografia italiana: un nome per tutti, Paola Barocchi. Non direi che le prospettive storiografiche siano o siano state differenti. Certo il declino dell’interesse per l’arte italiana nel mondo fa sì che oggi si debbano spiegare cose che un tempo erano date per scontate.
D - Che cosa significa Vasari per la cultura tedesca oggi?
Difficile dirlo. Sono rimasto io stesso molto sorpreso dal successo della nostra impresa. Il nome di Vasari è noto e rispettato: questo è già un dato confortante. In Germania c’è ancora un pubblico mediamente colto che ama molto l’Italia, la sua cultura e la sua arte. Vasari è una figura centrale di questo mondo, ma certamente è una pianta che va coltivata in una prospettiva che di giorno in giorno si fa sempre più globale.
D - Su quali temi si è focalizzato il recente convegno di Berlino?
Il convegno di Berlino non voleva essere trionfalistico, al contrario. Pertanto, le relazioni di Andreas Beyer e Tanja Michalsky, per esempio, hanno illustrato bene l’ideologia vasariana mettendo in luce le lacune del suo libro. Beyer ha analizzato i casi di Palladio, Cellini e Arcimboldi, marginalizzati o ignorati del tutto da Vasari, sostenendo che la linea palladiana, il cui libro in quattro parti non propone né un ritratto né un’autobiografia, fu più “moderna” in quanto si concentrava sulle opere più che sulle vite. Michalsky ha invece analizzato il caso di Napoli, quello che Giovanni Previtali definì un tempo la questione meridionale della storia dell’arte italiana. Marco Ruffini, invece, analizzando un documento inedito conservato nella biblioteca della Yale University ha avanzato un’ipotesi che, se dovesse risultare corretta, potrebbe stravolgere lo studio della nascita del testo vasariano recuperando, per via di confronti serrati, il manoscritto perduto ricordato in una lettera del 1547. Insomma, Vasari è una fonte inesauribile.
D - Come spiega che l’opera principale dello Schlosser, pubblicata originariamente a Vienna, sia oggi molto più conosciuta in Italia che nel mondo tedesco, al punto che il suo titolo italiano (Letteratura artistica) è divenuto la denominazione ufficiale dell’intera disciplina delle fonti della storia dell’arte, mentre il titolo tedesco (Kunstliteratur) non ha alcun significato generale?
In Germania non esistono cattedre di critica d’arte e forse questo può spiegare la sua domanda. Inoltre, come in tutti i paesi del mondo, persino in Italia, gli studenti sono sempre più attratti, per varie ragioni, dallo studio dell’arte contemporanea. Pochi si confrontano con testi complessi scritti in altre lingue, a volte obsolete. Comunque l’interesse per la Kunstliteratur sta riprendendo forza, in parte anche grazie alla nostra edizione che ha fatto da esempio. Un folto gruppo di studiosi sta preparando la prima edizione tedesca delle Vite di Giovan Pietro Bellori e Anna Schreurs e il suo team hanno commentato con grande perspicacia la Kunstakademie di Joachim von Sandrart. Insomma, qualcosa si muove. Aggiungo che due professori giapponesi stanno traducendo Vasari nella loro lingua e che il loro commento si basa in gran parte sul nostro.
D - Wagenbach è un grandissimo conoscitore dell’Italia, e la sua casa editrice ha contribuito negli ultimi cinquant’anni alla diffusione della letteratura e saggistica italiana contemporanea in Germania. Terminato il Vasari, vi sarà qualche altra sorpresa nel campo della letteratura artistica?
Come credo di avere già detto, stiamo approntando l’edizione tedesca delle Vite del 1550: la prima in assoluto, anche al di fuori della Germania.
D - In occasione del cinquantesimo anniversario, la casa editrice ha comunicato di aver trasferito i suoi archivi alla Staatsbibliothek di Berlino, in modo che possano essere oggetto di studio. Vi sono aspetti che dovrebbero attrarre l’attenzione degli studiosi della letteratura artistica?
Wagenbach è un grande studioso di Kafka e si occupa soprattutto di letteratura. Tuttavia, c’è nell’archivio una fitta corrispondenza con l’Editore Einaudi per una traduzione tedesca della prima edizione delle Vite. Allora non se ne fece nulla. Speriamo di riuscirci ora, in tempi ragionevoli.
https://letteraturaartistica.blogspot.com/2016/05/paola-barocchi25.html




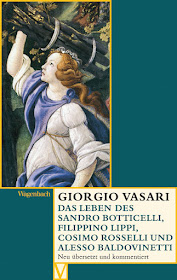







Grazie mille per questo articolo: da tempo vedevo nel catalogo Wagenbach via via la segnalazione delle nuove uscite dei volumetti delle Vite e mi chiedevo come fosse nata questa impresa editoriale. Grazie a Lei ho avuto una bella ed articolata risposta. Grazie ancora. Lorenzo Donati
RispondiEliminaGrazie a te! Giovanni
EliminaDavvero sconveniente Mein Leben, perché il Vasari scrive su di sé proprio a pari degli artisti di cui tratta, considerandosi uno di loro... Quel libro giapponese invece è uscito nel 2009, ma è vero che fu l'inizio di una nuova traduzione delle Vite
RispondiElimina